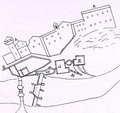Beni storici e artistici
Beni storici e artistici
Fermignano: Cartiera
La Cartiera di Fermignano si serviva dell'energia idrica del Metauro; in seguito venne trasformata in lanificio che disponeva di un impianto idroelettrico.
E' stata la più importante industria di Fermignano. Di questa attività, vitale per la
piccola cittadina, si ha notizia fin dal 1411, quando i Montefeltro danno in
gestione l'opificio a tre cartari di Fabriano, città dove la fabbricazione
della carta era già in pieno sviluppo.
Nel 1507 il duca Guidobaldo, figlio di Federico, dona la cartiera alla Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino; la
donazione servirà a garantire un sicuro e cospicuo introito per il
sostentamento di questa istituzione che aveva come fine lo studio e lo sviluppo
della musica sacra.
Alla cartiera viene concessa la "cenceria" (cioè l'appalto della raccolta degli stracci, materia
prima per la fabbricazione della carta) in tutto il ducato, e l'esclusiva della
vendita del prodotto finito negli stessi confini. Questi privilegi saranno
conservati anche dopo il 1632, quando il ducato di Urbino entrerà a far parte
dello Stato Pontificio.
Di proprietà dei Duchi prima, della Cappella poi, la cartiera non venne mai gestita direttamente, ma
sempre data in affitto. Se in un primo tempo i "mastri cartai" non
erano locali, successivamente la tradizione cartaria si consolidò con mastri e maestranze quasi tutte
fermignanesi.
Il conduttore della cartiera aveva l'obbligo di corrispondere un canone annuo e doveva garantire una produzione di
carta continua e costante per qualità e quantità, facendo salvi periodi di
guerra o di povertà d'acqua.
Dotata delle normali macchine con "pile" e "magli", vedrà l'installazione della sua prima
macchina "olandese" (unica vera novita' nella tecnologia cartaria dopo il XIV secolo) nel 1791, tra le prime dello Stato Pontificio.
In seguito, la scarsa manutenzione dovuta alla conduzione indiretta e il mancato rinnovo delle macchine, portarono
la cartiera verso un'inesorabile crisi che divenne defiitiva nel 1870, quando
l'opificio fu venduto.
Nel 1915 la fabbrica passò nelle mani della famiglia Carotti che la trasformò in filanda da seta e lanificio. Nel secondo dopoguerra fu completamente ammodernata ed ampliata, nella forma che ancor oggi è dato di vedere.
BIBLIOGRAFIA
LOCCHI 1934, p. 618
MARIANI 1994, pp. 213 - 230
VOLPE 1994, pp. 167 - 168
SGUANCI 1993, pp. 41-45.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 09.03.2001
Ultima modifica: 01.02.2008
Nessun documento correlato.