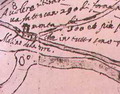Beni storici e artistici
Beni storici e artistici
I mulini idraulici nella storia e nel territorio
Introduzione
L'archeologia industriale ha anche il merito di aver posto all'attenzione tutti gli aspetti socio-antropologici e la dimensione architettonica dei luoghi del lavoro aggregato nella loro struttura obsoleta. Alte ciminiere in mattoni, massicce fabbriche in pietra, pensiline e strutture in ferro e vetro, centrali idroelettriche simili a cattedrali, villaggi operai, stazioni ferroviarie, ponti e opere idrauliche costituiscono i materiali più rappresentativi della rivisitazione critica della cultura architettonica sviluppatasi in Italia tra XIX e XX secolo a seguito della rivoluzione industriale.
Nelle Marche, per il grande peso che qui ha avuto l'agricoltura, con un sistema mezzadrile così diffuso e parcellizzato sull'intero territorio regionale per più di mezzo millennio, le industrie come d'altronde le metropoli non hanno avuto modo di svilupparsi, come invece è accaduto in altre aree. Non esiste dunque un patrimonio architettonico industriale consistente, tale da giustificare una storia e una tradizione specifica anche se alcune «officine» elettriche, le fabbriche metalmeccaniche di Pesaro, le cartiere Milani di Fabriano, i tabacchifici di Chiaravalle e Senigallia, le filande di Fossombrone, Osimo, Jesi e Ascoli Piceno, il lanificio ex-cartiera di Fermignano e certe strutture minerarie a Cabernardi e a Perticara di Novafeltria potrebbero indicare, senza alcun complesso di inferiorità, le tappe di un possibile itinerario attraverso le Marche, al passo con i processi industriali ottocenteschi cui facevano da supporto le forme attive di lavoro a domicilio, in città come in campagna (si pensi, ad esempio, alla rete produttiva agricola legata all'industria serica), alle quali tanto deve il successo del cosiddetto «modello marchigiano» degli ultimi decenni.
Queste tracce, per quanto significative, sono però sporadiche e di minor rilievo rispetto all'immagine classica delle Marche rurali, nelle quali piuttosto va cercato il tessuto produttivo a base artigianale, più proto-industriale che industriale, diversificato tra le varie aree sub-regionali, persino tra vallata e vallata, che caratterizza veramente la regione. Le fornaci di mattoni e laterizi, le fornacelle per la cottura della calcina, isolate o accorpate ad antiche cave e miniere, i mulini per la macinazione dei frumenti, i frantoi e i friscoli per l'olio, le gualchiere (o valchiere) e le conceríe lungo i tanti corsi d'acqua della regione, gli essiccatoi, le caciaie dei Sibillini, le carbonaie sull'Appennino, i piccoli cantieri navali, non ultimo i forni comunitari dei borghi rurali, le fontane e i lavatoi pubblici come luoghi del quotidiano lavoro femminile, i mercatali per le fiere del bestiame e le «piazze delle erbe», sono questi i luoghi più rappresentativi del lavoro di una regione agricola come le Marche. Tipologie costruttive spesso di dimensioni ridotte, mai monumentali, bene inserite nei contesti urbani come nei paesaggi agrari; strutture produttive e di scambio che più hanno integrato le attività e gli interessi della città con quelli della campagna; dove più si sono manifestati il rapporto e la simbiosi tra «fabbrica» e territorio, dove si è espresso più il valore del lavoro che quello della moderna macchina; strutture nelle quali è ancora evidente la stretta dipendenza dalle contigue fonti di energia come dalla localizzazione delle materie prime. Non ultimo, esse hanno fatto da supporto ai commerci, ai piccoli scambi, alle trattative e al baratto, essendo punti di incontro attorno ai quali sono sopravvissute a lungo piccole comunità.
Mulini a roteggio orizzontale e verticale
In un disegno di Antoine de La Sale, salito nel 1420 a Montemonaco per vedere l'antro della Sibilla, si vedono due mulini piceni a roteggio verticale esterno nella valle che si stende tra l'altura sulla quale sorge Montemonaco e la catena dei Sibillini.
Mulino a torre
Alla fine del Duecento e nel primo Trecento si approfondiscono le lotte per l'acquisizione dei mulini da parte del comune urbano, lotte nei confronti dei monaci e della proprietà signorile costretta a vendite coatte. In un documento malatestiano del 1455 e in un altro del 1493 riguardanti il territorio fanese, viene attestato il particolare tipo di contratto in locazione o a cottimo dei mulini il cui carattere pubblico è prevalente; in altri casi emerge l'impegno finanziario costante (e assai oneroso) della città per la loro manutenzione, nonché l'importanza fondamentale sotto il profilo strategico: la distruzione del mulino, o la deviazione del «vallato» che lo aziona, pone seri problemi alle popolazioni servite e scarse possibilità di resistenza nel caso di lunghi assedi. Il mulino fortificato o mulino a torre deve pertanto garantire la tutela della macchina e dei cereali in esso depositati. Sul territorio marchigiano il mulino medievale di tipo fortificato è ben documentato a San Polo sul Musone e a Castelraimondo.
I mulini idraulici nel 1800 e nel 1900
Ciò che è stato detto per il mulino dell'area europea è confermato da recenti studi storici marchigiani, i quali dimostrano la presenza capillare di esso, il suo stretto rapporto con l'estesa rete di microcittà, la presenza a tappeto della mezzadria e l'intensa coltura cerealicola che nel Novecento è stata spinta oltre i mille metri di altitudine. Pertanto il mulino rappresenta nelle aree collinari e montane delle Marche un servizio fondamentale per le popolazioni.
Il mestiere del mugnaio
Il mestiere di mugnaio, esemplificato da Carlo Ginzburg in "Il formaggio e i vermí", si trasmette per generazioni e generazioni all'interno della famiglia, la quale è anche depositaria di secoli di astuzie, tese ad ingannare il cliente, che a sua volta è estremamente diffidente del «molinaro». Nel mulino Patregnani sul Cesano, c'è ancora un Vinnaco (nome per altro assai diffuso nelle campagne marchigiane, che ricorda il San Vinnaco, ossia il monaco che - secondo la tradizione - avrebbe inventato la macina), con alle spalle la storia di una famiglia lì da sempre e un mestiere tramandato di padre in figlio; un padre-padrone che «si permetteva di riprenderci per una macina bilanciata male ascoltandone il rumore dalla lontana cucina; ma quello che sappiamo lo dobbiamo a lui come la scelta dei tronchi di quercia da cui prendevamo il marullo o merullo (il midollo del tronco), come chiamiamo nelle nostre campagne la parte più dura della quercia da usarsi per i meccanismi a diretto contatto con l'acqua. Una corretta regolazione della macchina era infatti importante per ottenere un buon prodotto lavorato». Le due macine (letto e corrente) dovevano essere regolate «giuste», cioè perfettamente complanari. Per fare questo si agisce sulla ralla che fa da perno al fusello: «di sopra si mette uno che dice ralla avanti, oppure ralla indietro, mentre una canna posta al centro dell'albero indica, prima di posare la macina, la sua verticalità rispetto al piano di rotazione di questa». Il carattere popolare del mulino a palmenti, oltre al rapporto strettamente funzionale con la vita delle campagne, sta nell'essere stato per secoli luogo di trasmissione culturale e di scambio di informazioni. Un detto nell'Osimano icasticamente afferma: «Grano di Montetorto, macina di San Polo, vino di Montepolesco», quasi a spiegare quanto un buon mulino abbia spazio nella cultura del quotidiano.
Il declino dei mulini
Con l'introduzione di nuove fonti d'energia, la struttura architettonica del mulino viene completamente modificata. L'impianto molitorio prevale sull'abitazione e l'architettura dell'edificío perde ogni riferimento alla struttura della casa colonica. Sono pochi i mulini superstiti, funzionanti con la sola energia idrica, «rilanciata» dalla lavorazione delle farine integrali. Ma anche essi sono destinati a scomparire presto; anche se l'ENEL progetta il riuso di diverse strutture abbandonate non sembra probabile che la ruota (ma saranno le turbine) torni a girare come in passato. Purtroppo, a differenza della casa di campagna, il mulino non trova, nel mercato dei rustici, estimatori e appassionati; la scarsa tutela del patrimonio storico-tecnologico espresso dai mulini ha fatto sì che anche le poche strutture recuperate e riattate abbiano definitivamente perduto in seguito ad interramenti e distruzioni del bottaccio e dei canali, con la rimozione delle macchine, i caratteri di distinzione tipici di questa architettura.
Il pesarese prefetto Scelsi, sul finire dell'Ottocento, mette in risalto il carattere di servizio e integrazione del reddito dell'attività molitoria dei piccoli mulini (in genere a una macina), descrivendo il divario esistente tra la produzione dei mulini di città e quelli delle aree rurali: «su 481 mulini, 469 macinano ogni anno meno di 5.000 quintali di grano, 10 meno di 10.000, 2 meno di 20.000, ed in particolare i mulini dei due maggiori comuni, Pesaro e Fano, con sette mulini e 20 palmenti producono un quantitativo di farina superiore a quella dei comuni di Urbino, Fossombrone e Cagli che dispongono di 85 mulini e 125 macine».
La deperibilità dell'edificio e la continua manutenzione alla quale deve essere sottoposto hanno portato alla scomparsa dei complessi molitori risalenti al periodo medievale, fatta eccezione per certi mulini a torre. Il nucleo più antico rileggibile in alcuni è databile dal XV al XVII secolo; più difficile è trovare i resti antichi delle opere murarie del canale (vallato) e delle chiuse, realizzate in genere in legno: delle parti, cioè, maggiormente assoggettate all'azione dell'acqua e alle continue modificazioni degli argini. Sole eccezioni la galleria della Sacca o Traforata a Serrungarina, nel Pesarese, unica nel suo genere, realizzata alla fine del '400, e quella del molino del Piano, presso Urbino, della seconda metà del Cinquecento, entrambe sul fiume Metauro. Negli altri casi si può al massimo risalire ai secoli XVII e XVIII, periodo nel quale si assiste a una sensibile trasformazione tipologica. Si passa cioè dall'edificio costruito in maniera organica, ossia per successivi aggiustamenti e crescite attorno al nucleo originario (molino di Tarugo, molino Bonci a Fossombrone), all'organismo regolare in pianta, in genere rettangolare o quadrata (molino Guarnieri di Vaccarile di Ostra, molino Piagnarelli sul Cesano), nel quale alcuni caratteri architettonici vengono accentuati: nel prospetto a valle predomina la simmetria e le bocche di uscita sul canale (gorgo) acquistano maggior peso nella composizione di facciata; sul «ponte» che scavalca il bottaccio si affacciano i locali destinati all'abitazione del mugnaio.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 01.01.1999
Ultima modifica: 10.01.2012
Nessun documento correlato.