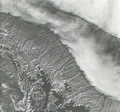Geologia e clima
Geologia e clima
Paesaggi costieri marchigiani (geomorfologia)
Tra tutti i sistemi naturali con cui l'uomo interagisce, le coste rappresentano quasi ovunque un sistema ad elevata fragilità sotto il profilo degli equilibri geologici ed ambientali. La posizione della linea di riva é estremamente sensibile a una complessa serie di fattori fisici e geologici che sono generalmente variabili nel tempo, di modo che essa può subire variazioni anche notevoli in brevi periodi. Quando poi questi fattori vengono pesantemente influenzati dagli interventi antropici, le variazioni si fanno più sensibili e possono assumere aspetti catastrofici per chi sulla costa vive e basa la propria economia. Il tutto é oggi apparentemente amplificato dal fatto che nell'ultimo secolo si é verificata, a livello globale, una fase di erosione generalizzata delle coste, che é coincisa con un processo di massiccio spostamento di popolazioni e attività verso le coste stesse; quanto più lo spazio costiero diventa prezioso per l'uomo, tanto più un arretramento della linea di riva, anche modesto, viene registrato con preoccupazione ed enfatizzato.
Durante gli ultimi due milioni d'anni della sua storia, il nostro
pianeta é stato soggetto a periodiche espansioni e ritiri delle calotte
glaciali circumpolari e dei ghiacciai montani. Durante le fasi di espansione
molta acqua veniva sottratta ai mari, provocando un abbassamento del livello
del mare. Per contro, durante le fasi di scioglimento e ritiro dei ghiacci il
livello marino saliva.
L'ultima fase di espansione glaciale, terminata circa
12.000 anni or sono, ha provocato un abbassamento del livello dei mari di
100-120 m rispetto all'attuale. La costa adriatica era ubicata circa
all'altezza di Pescara e delimitava una vasta pianura alluvionale, percorsa dal
Po e dai suoi affluenti tra cui vi erano i corsi d'acqua veneti, romagnoli e
marchigiani.
Il periodo geologico in cui viviamo, denominato Olocene, inizia
convenzionalmente nel momento in cui si afferma la tendenza ad una decisa
risalita del livello marino. Tale risalita non incontrò ostacoli sino a che la
linea di riva, regredendo, non lambì i rilievi pedappenninici. Il mare cominciò
ad aggredirli impostando gli imponenti processi erosivi che tutt'ora
proseguono. In corrispondenza delle valli poteva facilmente spingersi
all'interno, cosicché al termine del processo (circa 5.000 anni or sono) si era
formata una costa assai più articolata dell'attuale, con marcate sporgenze e
insenature.
La successiva evoluzione può essere definita, a grandi lineee, come
il realizzarsi di una tendenza alla rettificazione della linea costiera, con
arretramento dei promontori e avanzamento delle coste basse.
La costa nord-marchigiana costituisce un'unità morfodinamica complessa
formata da settori con problematiche differenti sia dal punto di vista morfologico
che evolutivo. Tratti di costa alta si alternano con litorali ghiaioso-sabbiosi
che corrispondono in genere alle piane alluvionali costiere dei fiumi
marchigiani e romagnoli.
La prima sporgenza a costa alta è il promontorio
pesarese di S. Bartolo, costituita da terreni miocenici prevalentemente
arenaceo-pelitici e strutturato secondo una serie di pieghe e sovrascorrimenti
con vergenza adriatica. La seconda prominenza, tra Ancona e Numana, costituisce il rilievo calcareo di più esterno
dell'Appennino centro-settentrionale. Si tratta di una struttura anticlinalica
fortemente asimmetrica, con asse orientato in direzione appenninica e vergenza
a nord-est.
Tra i due promontori esaminati si sviluppa un lungo tratto di costa bassa, ghiaioso-sabbiosa, che
borda i rilievi argillosi dell'Appennino pesarese-anconetano. La continuità dei
rilievi e delle strutture è ripetutamente interrotta dalle larghe piane
alluvionali e dagli apparati deltizi dei fiumi marchigiani. Questi tratti di
costa bassa che si intercalano ai promontori sono particolarmente importanti
per ricostruire l'evoluzione quaternaria recente dell'area. Essi hanno infatti
registrato le variazioni della linea di riva nell'Olocene. L'evoluzione
morfologica di queste paleorive ha messo in evidenza una forte tendenza alla rettificazione dell'intero tratto
costiero: i promontori che si protendevano nettamente verso mare sono stati
sottoposti ad attiva erosione mentre nelle foci fluviali le paleorive
oloceniche avanzavano verso mare con la costruzione di cordoni ghiaiosi spesso
anche di notevoli dimensioni.
Attualmente l'intero sistema costiero dell'Adriatico centrale è in erosione e ciò costituisce un problema sia per i
tratti a costa alta che per i litorali sabbiosi.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 01.01.1999
Ultima modifica: 21.02.2004
Nessun documento correlato.