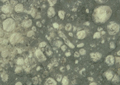Opere specialistiche
Opere specialistiche
LA VALLE DEL FIUME BOSSO, di Alberto Ferretti
Di questo lavoro esiste solo la presente stesura digitale (già comparsa nel 2007 nel sito della UNILIT - sede di Cagli).
Citazione bibliografica: FERRETTI A., 2012 - La Valle del Fiume Bosso. In: "La Valle del Metauro - Banca dati sugli aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro", http//www.lavalledelmetauro.it. Ed. Associazione Naturalistica Argonauta e Comune di Fano, Fano (PU).
-------------------------------
In memoria di don Mariano Mariotti
Introduzione
Una gola fluviale dalle forme aspre e selvagge, piante e animali provenienti da mille regioni che qui hanno trovato un rifugio sicuro, sorgenti d’acqua d’origine misteriosa, archi di roccia e variopinte pareti scoscese, caverne ricche di cimeli d’antiche civiltà: questa è la valle del F. Bosso, un piccolo corso d’acqua dell’Appennino marchigiano che può narrarci una storia lunga 200 milioni d’anni.
I suoi documenti sono molto semplici: rocce, fossili, piante e animali. Pagine di storia scritte nella pietra o nelle nicchie in cui vivono rare specie di organismi.
L’uomo vi è giunto per ultimo attirato dalle risorse naturali e dalla facile percorribilità della valle che gli permetteva di raggiungere rapidamente vaste regioni dell’Italia centrale.
Da secoli vi ha ricavato la pietra per i propri edifici. Il “travertino” così chiamato per la sua porosità prodotta da piccoli meati, ma molto resistente agli agenti atmosferici, distinto sulla base delle caratteristiche di lavorabilità in "travertino femmina", più tenero, e in "travertino maschio", più resistente.
La "pietra campanella", con tipi di più colori, talvolta ricca di vene spatiche chiamate "vermicelli", resistente agli agenti atmosferici e nient’affatto geliva.
Il “marmarone” dal colore bruniccio, nel quale i vecchi cavatori distinguevano il "marmarone unito", costituito da un impasto di frammenti di fossili e il cosiddetto "breccione", una varietà a grana più grossolana, formato da un impasto di frammenti calcarei e resti di fossili cementati da una pasta più fine.
E inoltre la “scaglia rosata”, la pietra universale, presente in tutti gli edifici del Cagliese, e la “pietra arenaria” impiegata nei portali, nelle soglie, negli scaloni dei palazzi.
Oggi i geologi chiamano queste pietre con altri nomi, ma alcuni ripetono quelli antichi. Pietre studiate per comprendere l’evoluzione nel tempo del nostro territorio che è poi una parte significativa della storia geologica del bacino mediterraneo.
Gli insediamenti umani
Italia centrale, Marche settentrionali, verso il confine con l'Umbria: da Cagli a Pietralunga viaggiate lungo la valle del F. Bosso. È la via più breve per raggiungere la valle del Tevere provenendo dalle regioni dell'Adriatico settentrionale. Non solo. È anche una via facilmente percorribile nel periodo invernale perché i valichi sono sempre a bassa quota e frane e piene non hanno mai rappresentato un grosso ostacolo.
Una via che scoprirono molto presto i nostri antenati che hanno lasciato le tracce della loro esistenza lungo tutto il percorso: dalle selci lavorate trovate nei pressi di Secchiano, alle sepolture d'età appenninica, ai cimeli dell'età del bronzo di Pieia. E poi gli Umbri, i Romani, i monaci avellaniti, che controllarono il traffico della valle costruendovi un eremo, e così via fino a noi.
La montagna umbro-marchigiana è poco popolata (anche meno di 30 abitanti per km2). I centri abitati non salgono oltre i 700 m e raramente superano i 1000. Essi sono per lo più ubicati sulla sommità delle colline o sui fondi delle valli maggiori che sono anche utilizzate dalle principali vie di comunicazione.
Fin dai tempi preistorici, dunque, l'uomo utilizzò le valli fluviali per i suoi spostamenti.
La storia dei primi abitanti del territorio è interessante, ma le conoscenze sono ancora incomplete. Dapprima l'uomo s'insediò probabilmente lungo la fascia costiera delle Marche e solo più tardi nella montagna appenninica sia perché il territorio costiero era più che sufficiente per le sue esigenze, sia perché la montagna in certi periodi era resa inospitale dai ghiacciai.
Nella montagna l'uomo trovò rifugio nelle numerose grotte, selce per costruire i suoi strumenti e le sue armi, abbondanza di animali e di frutti. La montagna, tuttavia, divenne sede di un importante popolamento solo con i pastori della civiltà appenninica che erano costretti a spostarsi con i loro greggi dalla costa ai pascoli montani con migrazioni stagionali. Queste genti, vissute circa 4000 anni fa, lasciarono numerose testimonianze della loro esistenza. Per le esigenze silvopastorali e per gli scambi commerciali utilizzarono le vie naturali rappresentate dalle valli fluviali. Le gole fluviali, infatti, permettevano di attraversare facilmente la catena e raggiungere la valle del Tevere. Anche oggi esse sono sede di importanti vie di comunicazione: la strada statale Flaminia che va da Roma a Fano; la superstrada Fano-Grosseto (ancora in via di completamento) ed altre strade d'importanza regionale o provinciale che corrono nelle stesse gole percorse dall'uomo preistorico. Oggi, però, le necessità di un traffico rapido e sicuro provocano troppo spesso la distruzione delle nostre belle gole fluviali che hanno conservato per moltissimo tempo i loro tesori naturali.
Nella valle del F. Bosso, in base alle caratteristiche geografiche del sito, i centri abitati si possono distinguere come:
- centri di fondo valle,
- centri su pendio,
- centri di sommità.
Sono centri di valle: Cagli, situato su un terrazzo fluviale alla confluenza dei fiumi Bosso e Burano; Pianello, ubicato allo sbocco della valle del T. Giordano in quella del F. Bosso; Secchiano, situato in un fondovalle d'erosione.
Sono centri su pendio: Cerreto, posto sul versante del M. Cimaio, Moria, Polea e Massa, situati su tratti pianeggianti di altri versanti montuosi. Fra i centri di sommità c’è Pieia che occupa però una posizione di sella.
I centri abitati si possono classificare anche rispetto alle vie di comunicazione. La rete stradale delle Marche segue il corso dei fiumi principali nella zona montana o nella bassa pianura; segue invece la sommità delle dorsali nella parte collinare della regione. La rete stradale, pertanto, è di tipo idrografico nella bassa pianura e nella zona montana, mentre nella zona collinare è di tipo orografico.
Con tali criteri possiamo distinguere i centri abitati della valle del F. Bosso in centri stradali, ossia centri allineati lungo una strada, e in centri di crocicchio posti all'incrocio di due o più vie.
Proviamo a descrivere alcuni centri sulla base di queste classificazioni, tenendo conto che oggi essi hanno perduto gran parte delle loro antiche funzioni. Cagli, ad esempio, aveva una posizione strategica perché posto su un terrazzo fluviale alla confluenza di due fiumi e allo sbocco delle lunghe e profonde gole del F. Burano e del F. Bosso. Centri di questo tipo furono preferiti dall'insediamento umano sia in epoca romana, per la sorveglianza della Flaminia e della Via per la Toscana, sia soprattutto in epoca medioevale quando le ragioni difensive ebbero la prevalenza su tutte le altre e quando perciò la popolazione si raccolse nella parte montana delle valli del F. Metauro e del F. Candigliano. Con i suoi due ponti, uno sul F. Burano ed uno sul F. Bosso, Cagli è al centro di un quadrivio formato dalle vie per Cantiano, Acqualagna, Piobbico (tramite Secchiano) e Pergola; rappresenta, dunque, un notevole centro di crocicchio nella valle del F. Candigliano e quindi del F. Metauro.
Anche Secchiano può essere classificato come un centro determinato dall'intersezione di strade importanti, specialmente nel passato.
Pianello è un centro posto allo sbocco di un corso d'acqua nella valle principale, ma esso è anche all'estremità di una gola fluviale in posizione tale da dominare gli incroci delle vie di comunicazione o comunque le strade che percorrono la valle. In passato la posizione di tali centri era, in un certo senso, privilegiata perché essi spesso si trovavano nella zona di contatto tra regioni a diversa economia. Le aree lungo l'alveo fluviale, tuttavia, dovevano essere evitate per le scarse condizioni igieniche dovute anche alla lavorazione delle fibre tessili o delle concerie.
Pieia, invece, ha caratteri del tutto differenti essendo un centro di sella. Occupa una selletta fra due poggi calcarei, isolati dall'erosione, nella parte più alta del versante meridionale della Montagnola e cioè in un punto di più facile transito.
Altri elementi aiutano a comprendere ancor meglio la scelta del sito dei centri abitati, in particolare certi loro allineamenti in senso NO-SE. Dal centro principale che caratterizza questi allineamenti possiamo chiamarli: 1) allineamento di Cantiano; 2) allineamento di Piobbico; 3) allineamento di Cagli.
1) L'allineamento di Cantiano comprende: S. Andrea , S. Lorenzo di Carda, Colombara, S. Cristoforo di Carda, Serravalle di Carda, Valdara, Massa, Pianello, Moria, Palcano, Pontedazzo, Cantiano.
2) L'allineamento di Piobbico comprende: Piobbico, Acquanera, Bacciardi, Cardella, Cuppio, Fosto, Secchiano.
3) L'allineamento di Cagli comprende: Orsaiola, Naro, S. Vitale, Cagli, Acquaviva, Paravento.
Tale disposizione perfettamente allineata dei centri abitati deve avere una spiegazione.
Possiamo constatare che S. Cristoforo di Carda, Serravalle, Valdara, Massa, Pianello, Moria, Palcano sono allineate fra loro e stanno tutte sulla Scaglia Cinerea o sulla contigua formazione rocciosa del Bisciaro e più precisamente su ripiani a debole inclinazione.
La stessa cosa succede per Pieve d'Acinelli, Piobbico, Acquanera, Rocca Leonella, Fosto, Secchiano, ed inoltre per Abbadia di Naro, S. Vitale, Cagli, Acquaviva.
I fattori da prendere in considerazione per spiegare l'ubicazione dei centri abitati nella catena del Catria possono allora essere: fattori geologici, geomorfologici, idrografici, pedologici e geografici, questi ultimi in relazione con l'altitudine e con l'esposizione dei versanti.
La struttura geologica delle dorsali montuose è determinante sulla localizzazione dei centri abitati. La catena del Catria, per la sua struttura ad anticlinale, possiede una certa simmetria delle formazioni rocciose che la costituiscono.
I centri abitati stanno per la maggior parte su una striscia rocciosa di Scaglia Cinerea e Bisciaro, quasi sempre a quote basse, ai piedi del M. Nerone, del M. Petrano o del M. Catria.
Non è dunque solo l'altitudine che condiziona l'insediamento, ma un importante fattore è la natura litologica delle montagne. Nel territorio ad occidente d'Apecchio, ad esempio, i centri abitati raggiungono quote molto più alte che nella montagna del Nerone o del Catria perché essi sono ubicati su formazioni di natura diversa.
Il nucleo calcareo della catena appenninica, difficilmente erodibile, è circondato da rocce marnose o arenacee che sono invece facilmente erodibili. Ciò ha determinato la formazione di ripiani orografici che hanno favorito l'insediamento umano.
Le sorgenti hanno avuto una parte determinante sull'ubicazione dei centri abitati. Nel nostro territorio gli orizzonti acquiferi, ossia le rocce che determinano l'emergenza delle acque e, dunque, le sorgenti, coincidono con le rocce marnoso-argillose. Ebbene, gran parte dei nostri centri abitati sorgono su tali rocce e quasi sempre in vicinanza di sorgenti d'acqua. Per di più l'orizzonte sorgentifero principale è situato a quote generalmente basse, intorno ai 500 m, ed è un altro fattore correlabile con la bassa altitudine degli insediamenti.
Bisogna poi osservare che la maggior parte dei centri abitati ha un'esposizione a sud, ossia sono stati preferiti i versanti più caldi, le posizioni a solatio, che favoriscono un più rapido scioglimento delle nevi e migliori condizioni di luce.
Il versante a bacìo è in generale più umido. La quantità di calore solare, infatti, ricevuta dai versanti di una valle può essere molto differente. Il versante esposto a solatio riceve spesso una quantità di calore superiore al doppio rispetto al versante a bacìo.
La conseguenza è che nel versante a solatìo il grado d'evaporazione è maggiore e pertanto è minore l'acqua contenuta nel suolo per cui la copertura vegetale è più rada e più povera rispetto a quella dell'altro versante. Tuttavia l'attività agricola si è sviluppata di più sul versante soleggiato rispetto a quello a bacìo dove prevale il bosco.
La presenza di rocce calcaree ostacola lo sviluppo dell'agricoltura perché il terreno calcareo non favorisce la formazione di suoli profondi. Ciò, invece, non avviene con le rocce marnoso-arenacee sulle quali troviamo case sparse, ossia poderi e perciò agricoltura, anche a quote abbastanza elevate. E' importante rilevare che passando dai terreni più “teneri” di tipo marnoso-arenaceo ai terreni calcarei si doveva cambiare il mezzo di trasporto: sulle rocce tenere era infatti possibile utilizzare il carro con ruote e le strade erano anche abbastanza larghe; sulle rocce calcaree, invece, si doveva utilizzare il trasporto su muli lungo vie strette dette, appunto, mulattiere.
Nel passaggio dalle strade aperte su rocce tenere a quelle aperte su rocce dure dovevano esserci zone di sosta per il cambio del mezzo di trasporto e pertanto in quei punti potevano facilmente sorgere degli edifici, delle abitazioni.
La natura delle rocce, le forme del paesaggio, le sorgenti e i corsi d'acqua, le differenze climatiche dei versanti sono, dunque, fattori che dobbiamo tener presenti se vogliamo comprendere la scelta del posto in cui i nostri antenati costruirono le loro dimore.
Aspetti del paesaggio
La montagna del Nerone è piena di spaccature, ripari sottoroccia e caverne scavate nel Calcare Massiccio. Probabilmente all'interno della montagna esiste un sistema di cavità carsiche ancora per la maggior parte sconosciuto. Le acque che lo percorrono potrebbero essere quelle che hanno il loro sbocco nella sorgente del Giordano, nei pressi di Pieia, e che a Pianello confluiscono nel F. Bosso.
Lungo il corso del torrente Giordano, a diverse altezze nella gola che esso ha inciso, si possono osservare bellissime marmitte d'erosione che testimoniano l'evoluzione del livello fluviale nel tempo. In questa vallata il fenomeno carsico più sorprendente è l'arco naturale di Fondarca. Uno stretto sentiero conduce da Pieia all'arco naturale che immette in quella che un tempo era una vasta caverna. L'arco è ciò che è rimasto della volta di una caverna, in parte distrutta da crolli e processi erosivi. Il fondo della caverna è riempito da una gran massa di frammenti rocciosi. Dalla parte opposta dell'arco, uno stretto passaggio permette di uscire in una forra da cui si può vedere un panorama selvaggio di notevole bellezza.
L'origine del complesso carsico di Pieia potrebbe essere posta in relazione con l'azione di un antico sistema di corsi d'acqua che, durante il Pleistocene, ha dapprima agito in superficie e successivamente all'interno del massiccio calcareo. In questo caso però le cavità carsiche dovrebbero essere distribuite su più piani connessi con terrazzi fluviali che si dovrebbero trovare all'esterno e cioè nella valle dello stesso corso d'acqua.
Proprio per la mancanza di tali evidenze, non tutti gli studiosi concordano con questa spiegazione dell'origine del carsismo di M. Nerone. L'analisi delle forme di superficie porterebbe infatti ad escludere l'esistenza di un paleo-fiume. Le modeste dimensioni del bacino d'assorbimento delle acque meteoriche fanno ritenere che il carsismo del M. Nerone debba essere ricondotto, invece, all'azione di acque provenienti dalla fusione di un ghiacciaio. Una morfologia di tipo glaciale, ad esempio, si può riconoscere nella conformazione della stessa conca di Pieia e da depositi detritici che alcuni autori hanno identificato con morene. Sarebbero state dunque le acque di fusione del ghiacciaio che, infiltrandosi nel massiccio carbonatico, avrebbero alimentato le falde sotterranee responsabili della formazione delle grotte. Al termine della fase glaciale subentrò una nuova fase d'attività carsica, che è definita di tipo vadoso, alla quale si deve lo scavo di pozzi e forre.
Un altro imponente aspetto del paesaggio nella valle del F. Bosso è rappresentato dalla gola fluviale tra Pianello e Secchiano. Con questa gola il Bosso ha superato la linea che collega le vette dei monti Nerone e Petrano (detta linea di massimo rilievo o asse orografico).
Per interpretare questo fenomeno si possono usare due ipotesi. La valle attuale potrebbe essere la testimonianza di un antico percorso fluviale che attraversava un territorio pianeggiante il quale successivamente è stato coinvolto nel sollevamento della catena montuosa. Se il tracciato fluviale si è mantenuto costante nel tempo, a tale processo si dà il nome di antecedenza. Supponiamo invece che il fiume abbia scavato il suo antico corso in rocce tenere, ma, a mano a mano che lo approfondiva, abbia incontrato rocce sempre più resistenti senza avere più la possibilità di modificare il suo tracciato. In questo caso si parla di sovrimposizione. È a questi due processi o ad una loro combinazione che possiamo attribuire l'origine delle gole fluviali appenniniche.
La gola del F. Bosso, con il suo andamento perpendicolare alla dorsale appenninica, è una tipica valle trasversale.
Valli longitudinali sono quelle che hanno la stessa direzione della dorsale montuosa;
valli trasversali sono, invece, quelle perpendicolari ad essa e valli oblique quelle con altre direzioni.
Più a valle, poco prima di Cagli in località Tre Pozzi, il Bosso ha realizzato un'originale incisione nei calcari della Scaglia Rossa. Gli strati calcarei, in questo sito, presentano una caratteristica pieghettatura che ricorda i galloni, ossia quei distintivi dorati che portano i militari come segno di riconoscimento del loro grado. Tale pieghettatura è stata prodotta dagli spostamenti subiti dagli strati rocciosi durante il sollevamento della catena montuosa. I sovrascorrimenti tra strati sono facilitati non solo dall’alternanza di materiali calcarei o argillosi, ma soprattutto a causa delle elevate pressioni cui erano sottoposti i fluidi interstiziali a causa delle spinte orogenetiche.
La piccola gola dei Tre Pozzi è un sito singolare e di gran pregio paesaggistico che si ritrova solo in poche altre situazioni, ma mai in maniera così netta e così facilmente accessibile alle persone. In estate è un luogo di ritrovo per fare il bagno nelle fresche acque del F. Bosso. Un’accentuazione delle caratteristiche rupestri del sito è data dallo sperone roccioso che scende dal monte S. Maria, elemento del paesaggio veramente degno di tutela.
Nella parte del bacino che il F. Bosso ha strappato ai corsi d'acqua affluenti del Tevere, il substrato roccioso è rappresentato dalla Formazione Marnoso-Arenacea. Qui gli eventi franosi sono più frequenti. Gli strati arenacei di questa formazione rocciosa sono permeabili all’acqua, quelli marnoso-argillosi sono, invece, impermeabili. Se la presenza d'acqua è abbondante negli strati arenacei più superficiali ed alterati, può succedere che i granelli che formano tali strati perdano il contatto l'uno con l'altro: è come se galleggiassero nell'acqua stessa. In particolari condizioni di giacitura di tali strati e cioè quando essi hanno lo stesso andamento del versante, ma un'inclinazione minore (strati a franapoggio), questa perdita di contatto tra i granelli per la presenza d'acqua, ma anche per il peso degli stessi strati rocciosi, è la causa delle frane.
La vegetazione
I dintorni di Pieia hanno un notevole valore botanico per la presenza di un'interessante vegetazione (1). Tra le rupi rocciose sono intercalati lembi di bosco più o meno degradato (querceto xerofilo, pseudomacchia a leccio e orniello, lembi di faggeta presente con individui cespugliosi) e piccoli pascoli sottoposti a sfalci periodici. Qui si trovano a breve distanza specie erbacee che crescono solo nei boschi (specie nemorali), altre che vivono solo su un substrato roccioso (specie rupicole) ed altre ancora tipiche dei pascoli (specie pabulari) molte delle quali sono conosciute solo in poche località delle Marche, come Campanula latifolia (che vive nei boschi mesofili elevati), Digitalis ferruginea (una scrofulariacea che vive nei boschi e pascoli degradati), Rosa pimpinellifolia, Solenanthus apenninus, Veratrum album lobelianum (liliacea che, in tutte le Marche, è presente solo nel M. Nerone).
Le specie che hanno maggior interesse scientifico sono rappresentate da Lonicera alpigena, un arbusto piuttosto raro (anche nei Sibillini) e dal crespino (Berberis vulgaris) pianta rarissima che, in tutte le Marche, sembra presente solo in questo sito. Probabilmente parecchie specie vegetali qui rappresentate sono dei relitti, sopravissuti ai periodi glaciali e interglaciali pleistocenici, che provenivano da regioni balcaniche, pontiche o mediterranee.
In realtà tutta la flora della valle del F. Bosso è una miniera di prezioso materiale di studio caratterizzata da una notevole ricchezza di specie ciascuna delle quali però è spesso rappresentata da pochi individui. La maggior parte di queste specie vegetali sono elementi floristici rari o rarissimi non solo nella regione marchigiana, ma in tutta la catena appenninica e, in qualche caso, perfino nell’intera penisola italiana.
Il fatto singolare della valle del Bosso, in particolare della sua gola, è dato dalla convergenza di specie vegetali provenienti da regioni euro-asiatiche molto diverse.
In generale la flora delle gole appenniniche marchigiane comprende quattro gruppi di vegetali:
- gli elementi mediterranei,
- gli elementi pontici, tipici delle regioni steppiche;
- gli elementi balcanici o periadriatici;
- gli elementi alpini.
Per comprendere a fondo questi fenomeni bisogna ricorrere ai tipi di clima che hanno dominato sulla nostra regione da 3-4 milioni di anni fa fino ad oggi. Le specie vegetali delle gole appenniniche sono infatti la testimonianza di complessi fatti paleoclimatici e paleogeografici. I numerosi endemismi sono rappresentati:
- da relitti di specie giunte in età pliocenica o pleistocenica,
- da specie che, in generale, vivono su alte montagne ed invece, nelle gole appenniniche, scendono a quote molto basse,
- da specie che altrove vivono sui litorali,
- da specie tipiche dei boschi ombrosi che vivono qui nelle umide e fresche anfrattuosità dei versanti rocciosi. Queste specie endemiche devono la loro sopravvivenza a svariate situazioni microclimatiche presenti nelle gole.
Le gole appenniniche, infatti, hanno spesso una direzione trasversale rispetto alla catena montuosa per cui un versante della gola risulta esposto a sud, l'altro a nord. Tale orientazione determina condizioni ambientali differenti e quindi caratteristiche vegetazionali diverse.
Nella valle del F. Bosso possiamo distinguere alcune tipiche aree vegetazionali che coincidono con:
- il letto maggiore del corso d'acqua;
- la zona d'affioramento del Calcare Massiccio;
- i versanti della gola fluviale.
In esse le principali unità fitosociologiche sono:
- i boschi di faggio;
- i querceti xerofili a leccio;
- i boschi a orniello e carpino;
- il querceto a roverella;
- la vegetazione ripariale con pioppi e salici.
I boschi degli alvei fluviali sono caratterizzati da specie arboree igrofile quali pioppo bianco (Populus alba), ontano nero (Alnus glutinosa), tiglio (Tilia platyphyllos), olmo campestre (Ulmus minor) e da varie specie di salice (Salix purpurea, S. alba). Procedendo dall'alveo verso la periferia del letto maggiore si ha una distribuzione di specie caratterizzata dapprima da una vegetazione a salici bassi, cui segue una fascia di salici arbustivi e poi da individui arborei di salice o di pioppo. In questo ambiente è spesso presente il sambuco.
Il querceto a roverella è caratteristico delle zone collinari. Nei querceti a roverella si trovano anche altre specie arboree o arbustive tra cui l'acero trilobo (Acer monspessulanus) e l'acero minore (Acer campestre). Tra gli arbusti è presente il biancospino (Crataegus laevigata), il corniolo (Cornus mas), il ciliegio canino (Prunus mahaleb) e il prugnolo (Prunus spinosa). Il querceto a roverella è presente sui substrati marnoso-arenacei, specialmente dei versanti esposti a sud. L'area di distribuzione del querceto a roverella corrisponde alla fascia collinare fino ai 1000 metri d’altitudine. In realtà nelle Marche questa fascia altimetrica è intensamente coltivata per cui si trovano soltanto pochi boschi residui di questo querceto. Oggi la roverella è più frequente come albero isolato o disposta in filari lungo le vie di comunicazione di minor importanza.
I boschi di carpino (Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus) sono presenti sui versanti della gola del F. Bosso. A queste due specie sono associati vari aceri (Acer obtusatum, A. campestre, A. monspessulanum), sorbi (Sorbus terminalis, S. domestica) e il ciliegio canino (Prunus mahaleb). Fra gli arbusti sono frequenti i biancospini (Crataegus monogyna, C. laevigata), la sanguinella (Cornus sanguinea), il corniolo (Cornus mas), il nocciolo (Corylus avellana), la berretta da prete (Euonymus europaeus) e il borsolo, detto anche paternostri (Staphylea pinnata), un arbusto con caratteristici frutti vescicolosi, abbastanza raro, Arum maculatum, Cardamine bulbifera, Galium odoratum ed inoltre Arisarum proboscideum, un'aracea che è considerata un endemismo appenninico. Questa associazione è presente nei versanti freschi, generalmente esposti a nord, su substrati calcarei.
La cerreta caratterizza la zona superiore del piano submontano fino a 1000 m. Il cerro (Quercus cerris) è infatti condizionato da un clima fresco e da suoli con reazione acida. Dal cerro prende il nome la frazione di Cerreto e probabilmente anche uno dei principali affluenti del F. Bosso e cioè il Certano o Giordano che in passato era chiamato Cerretano.
Il faggio (Fagus silvatica) è la specie più significativa della montagna appenninica. La faggeta è un'associazione vegetale sviluppata fra 900 e 1400 m, ma attualmente ridotta per lo più allo stato arbustivo a causa della ceduazione. Esemplari di Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Acer opalus s’associano al faggio a seconda delle condizioni ambientali. In generale però il faggio forma dei boschi monospecifici. Lungo il bordo delle faggete e in alcune radure sono presenti numerose specie di erbe alte fra cui la belladonna (Atropa belladonna), il crisantemo (Chrysanthemum parthenium), il giglio martagone (Lilium martagon) e il geranio con i petali ribaltati all'indietro (Geranium reflexum). Si può trovare l'agrifoglio (Ilex aquifolium), l'acero riccio (Acer platanoides), l'acero di monte (Acer pseudoplatanus).
Il leccio è una specie abbastanza comune, isolato o a piccoli gruppi, in posizioni rupestri soleggiate su un substrato di calcari compatti, come avviene nei dintorni di Fondarca. La lecceta tuttavia è spesso ridotta allo stato arbustivo (macchia).
La fauna
La fauna della valle del F. Bosso è tipicamente appenninica.
Le acque del F. Bosso sono classificate come acque da salmonidi. È infatti presente la trota, ma anche il gambero di fiume e il granchio di fiume. La presenza di tutte queste specie sta a significare che il Bosso è un corso d'acqua ancora integro.
Le acque del F. Bosso ospitano un pesce particolare, localmente chiamato "capesciotto - capsciott" per le dimensioni del suo capo. Sotto questo nome sembra che siano localmente conosciute due specie distinte, e cioè Cottus gobio e Gobius nigricans. Tortonese (2) esaminò otto esemplari di Cottus gobio provenienti proprio da Cagli. Gobius nigricans vive nelle acque del F. Bosso e degli altri corsi d'acqua della parte montana del bacino del F. Metauro (3).
In ogni caso, per molti aspetti si tratta di specie importanti che dovrebbero essere più tutelate, specialmente da forme d'inquinamento biologico, ossia dalle periodiche immissioni di trote. Nelle acque del F. Bosso vivono anche il cavedano e il barbo.
Tra gli anfibi sono presenti diverse specie comuni come il rospo, la rana verde, la raganella, il tritone crestato.
I rettili piu comuni sono il ramarro, la lucertola e l'orbettino e, tra i serpenti legati all'ambiente acquatico, la natrice dal collare. Frequente è il biacco, anche con la sua varietà carbonaria. La vipera è presente, probabilmente con una consistenza inferiore alle errate segnalazioni.
La distribuzione degli uccelli varia con l'ambiente. Specie comuni nell'ambiente fluviale sono la gallinella d'acqua ed il martin pescatore; nei boschi o nei pascoli sono frequenti la poiana, l'upupa, il fiorrancino, la cincia, il picchio muratore, la ghiandaia, le silvie, il merlo, l'usignolo, l'averla piccola, lo zigolo, l'allodola; nelle zone rupestri le specie più comuni sono il gheppio e la taccola e per finire la rondine e il balestruccio. Una coppia di aquile da un po' di tempo è tornata a volteggiare sul Nerone.
Tra i mammiferi le principali specie sicuramente presenti sono: la volpe, la donnola, la faina, il tasso, lo scoiattolo, il moscardino, il toporagno, il topo selvatico, il topo campagnolo, la lepre, il cinghiale, il riccio. È sempre più spesso segnalata la presenza del lupo.
Le formazioni rocciose
Sulla destra del fiume, al nono chilometro circa della strada Cagli-Pietralunga, c'è un'interessante parete rocciosa che si può osservare molto bene dalla strada. Alcuni strati appaiono fortemente contorti e spezzati, altri invece sono continui con qualche piccola piega a ginocchio. Gli strati spezzati e contorti costituiscono grossi pacchi di materiali posti tra gli strati continui: essi rappresentano una struttura sedimentaria chiamata “slumping”. La formazione rocciosa in cui sono presenti tali slumpings è detta "Formazione del Bosso"; la parte più bassa è costituita dal Rosso Ammonitico che qui, però, è piuttosto povero di ammoniti.
Nell'ultimo strato della sottostante Formazione della Còrniola sono presenti, invece, numerose Ammoniti appartenenti alle specie Dactylioceras mirabile, D. pseudocommune, D. simplex, Protogrammoceras bassanii che permettono di attribuire tale strato al Toarciano basale (4).
Gli slumpings sono un importante elemento per ricostruire l'antico assetto paleogeografico. Si ritiene infatti che essi siano stati prodotti dallo scivolamento di sedimenti, non ancora consolidati, lungo superfici inclinate. Ciò fa pensare che nel Giurassico inferiore l'area corrispondente alla catena appenninica umbro-marchigiana fosse costituita da rilievi e depressioni sui quali s’estendeva il mare. I sedimenti deposti sui versanti dei rilievi sottomarini subivano periodicamente delle sollecitazioni per cui scivolavano verso i fondali più profondi. Le strutture sedimentarie che si vedono nella parete rocciosa della gola del F. Bosso sono appunto la testimonianza di tali franamenti. Probabilmente questi furono provocati non solo dall'instabilità propria di quei sedimenti, ma anche da fenomeni sismo-tettonici. Dobbiamo cercare, ora, di riconoscere il rilievo sottomarino sul quale poggiavano i sedimenti franati. Sembra logico pensare che si tratti di un’area nella quale mancano parti consistenti della normale successione rocciosa. Ciò, però, potrebbe dipendere anche dal fatto che tale successione non fu mai deposta. Occorre, dunque, procedere con cautela e interpretare correttamente i segni, i documenti, registrati negli strati rocciosi.
Il primo problema da risolvere è la ricostruzione della successione rocciosa completa (o continua) del nostro territorio.
Nella valle del F. Bosso la più antica formazione rocciosa è rappresentata dal Calcare Massiccio (in passato chiamato “travertino”) che affiora nei dintorni di Pieia. È un calcare di color biancastro con sfumature rosate e una patina d’alterazione grigia. Spesso è vacuolare. La stratificazione è in grosse bancate di 4-5 m, talvolta anche di più; solo nella parte terminale compaiono degli strati. Nel Calcare Massiccio i fossili sono rari e mal conservati. A volte si possono trovare conchiglie di molluschi, generalmente gasteropodi. L'analisi di sezioni sottili al microscopio mette, invece, in evidenza parecchi microfossili. La presenza di oncoidi, ben visibili sulla superficie di uno strato che affiora lungo la strada carrareccia che da Pieia porta al Nerone, indica che l'ambiente di sedimentazione doveva essere lagunare, ma caratterizzato da acque in movimento. Questo, infatti, è attualmente l'ambiente in cui essi si formano. In sezione, gli oncoidi mostrano una struttura a lamine prodotta dalla sovrapposizione concentrica di resti di alghe intorno ad un nucleo costituito da un granulo minerale. Tutto ciò è il risultato del rimaneggiamento di alghe, trasportate dal moto ondoso o da correnti, che finiscono poi per agglutinarsi intorno a particelle sabbiose. Questi caratteri, dunque, permettono di dire che il Calcare Massiccio si è formato in un ambiente marino di acque poco profonde.
Altri documenti di grande interesse sono i dicchi nettuniani prodotti da deformazioni dei sedimenti che avvenivano contemporaneamente al loro deposito (deformazioni sinsedimentarie). I dicchi nettuniani sono formati dal riempimento di fessure subverticali beanti per mezzo di materiali, non ancora consolidati, deposti in vicinanza della loro apertura superiore. I dicchi possono infossarsi nel substrato roccioso anche per più decine di metri, mentre la loro larghezza non supera qualche decimetro. Essi sono la conseguenza di una fratturazione delle rocce dovuta a dislocazioni tettoniche, in particolare a faglie. Per questo motivo sono disposti con un orientamento ben definito. I dicchi, inoltre, sono riempiti da materiali che stanno al di sopra di quelli che essi attraversano. Anche per questo motivo i dicchi nettuniani sono caratteristici di zone elevate perché in queste si formano più facilmente fratture per brusche decompressioni le quali poi si riempiono di materiali vari.
Lo spessore del Calcare Massiccio pone un altro interessante problema: come è possibile che in un mare poco profondo si sia deposto tanto materiale da dare origine a più di 700 m di rocce? I geologi spiegano questo fatto ammettendo che il fondo del bacino marino sprofondasse lentamente durante il deposito dei sedimenti che costituiscono il Calcare Massiccio. La velocità di accumulo dei sedimenti era allora uguale alla velocità di sprofondamento del fondale marino, per cui lo spessore del mare restò identico per un lunghissimo periodo di tempo. Questo fenomeno è chiamato subsidenza.
Al di sopra del Calcare Massiccio sta la Còrniola, una formazione rocciosa ben stratificata, costituita da calcari compatti, talvolta marnosi, di color grigio-chiaro, talora rossiccio, in strati da piccoli a grossi, spesso ricchi di selce varicolore, con interstrati marnoso-argillosi grigio-verdastri o rossastri. La parte inferiore della Còrniola è caratterizzata dalla presenza di calcari prodotti dall'accumulo di particelle detritiche che derivano quasi sempre da gusci di animali (calcari bioclastici o calcareniti). Questa parte della formazione rocciosa è detta Marmarone ed è anche ricca di selce. Nelle successioni continue lo spessore della Còrniola può raggiungere 150-180 m.
Il sovrastante Rosso Ammonitico è costituito da marne e da calcari marnosi d’aspetto nodulare, ben riconoscibile per il suo colore e per la presenza di ammoniti. Oggi il Rosso Ammonnitico non è più considerato una formazione rocciosa indipendente, ma è il membro inferiore della Formazione del Bosso; i sovrastanti Calcari a Posidonia rappresentano il membro superiore.
La Formazione del Bosso, dunque, procedendo dai livelli più recenti ai più antichi, ossia dall'alto al basso, comprende:
2) un membro superiore, prevalentemente calcareo e ricco di selce, ma con un contenuto marnoso-argilloso che cresce sempre più scendendo verso il basso;
1) un membro inferiore decisamente marnoso.
Certi livelli argillosi, nerastri, del membro inferiore, possono essere considerati equivalenti ad una formazione ben sviluppata in Umbria, nel M. Serrone, da cui il nome di Marne del Serrone.
Lo spessore della Formazione del F. Bosso varia da 20 a 70 m.
Sopra la Formazione del Bosso compaiono dei calcari ben stratificati, con selce in straterelli o in noduli. Il loro spessore complessivo varia da 70 a 100 m. Si tratta dei Calcari Diasprini, una formazione rocciosa costituita da calcari granulari, più o meno selciferi, di colore grigio, grigio-verdastro o grigio-nocciola, con selce varicolore. La parte mediana della formazione è più ricca di selce rispetto alla parte inferiore o superiore che sono invece più calcaree.
La parte sommitale dei Calcari Diasprini è rappresentata dai cosiddetti Calcari a Saccocoma ed Aptici.
Lo spessore complessivo della Còrniola, della Formazione del F. Bosso e dei Calcari Diasprini raggiunge o supera i 300 m.
In queste formazioni rocciose sono presenti quei pacchi di strati molto deformati, ripiegati su se stessi, che sono il risultato di frane sottomarine (slumpings). Si è già detto che questo è un elemento diagnostico, importantissimo per la paleogeografia, perché le frane di qualsiasi tipo avvengono lungo pendii. Ciò implica l’esistenza di un punto più in alto, dal quale partono i materiali, e di un punto più in basso, nel quale essi si fermano.
La Còrniola, la Formazione del Bosso e i Calcari Diasprini possono essere assunti come una successione di riferimento o "normale". Gli ambienti di deposito dei sedimenti, che hanno dato origine alle tre formazioni, erano ambienti di mare aperto e abbastanza profondo, interpretazione giustificata anche dall'abbondanza delle selce. Il mare, tuttavia, non doveva avere una profondità uniforme. In alcune località della valle del F. Bosso affiorano infatti delle successioni, paragonabili alla Còrniola, alla Formazione del F. Bosso ed ai Calcari Diasprini, ma con lacune e spessori molto diversi.
Perché mancano i sedimenti corrispondenti alle lacune?
Tutto ciò potrebbe dipendere da fenomeni eteropici o da condensazioni?
Forse non si sono deposti i materiali?
Oppure sono stati erosi da forti correnti marine?
Sono franati?
Ci stiamo avvicinando alla scoperta dell’antica montagna sottomarina?
Per comprendere meglio questi fatti possiamo tener presente la morfologia dell'arcipelago delle Bahamas in cui vi sono isole vicine fra loro separate da profondi solchi marini. In questo arcipelago coesistono ambienti di sedimentazione molto diversi, a breve distanza, per cui è possibile avere:
1) eteropie di facies,
2) serie lacunose sui cosiddetti alti strutturali (che sono i rilievi che stiamo cercando) perché le correnti marine impediscono il deposito di materiali;
3) sedimentazione indisturbata nei bacini profondi, ma anche bacini profondi a ombelico, chiusi da alti strutturali;
4) frane (slumpings) che scendono lungo i versanti degli alti strutturali fino al fondo del bacino.
Lungo la strada che porta a Pieia c'è una piccola cava, non più coltivata, in cui si può osservare una di queste successioni rocciose particolari. Un'altra è rappresentata dagli strati che si vedono nella cava del Fosso Bugarone. Qui compare un modesto affioramento di calcari con molti noduli che, in generale, sono connessi a conchiglie d'ammoniti. Dal nome della località essi costituiscono la Formazione del Bugarone che risulta composta da più membri:
4) Calcari marnosi nodulari ad Aptici;
3) Calcari nodulari nocciola o rosati;
2) Calcari nodulari con marne verdi;
1) Calcari stratificati grigio-nocciola.
In altri siti i Calcari nodulari ad Aptici possono essere sostituiti da rocce ricche di selce.
Una lacuna di sedimentazione è stata documentata quasi a metà della successione. Studiando infatti le ammoniti presenti, risulta una mancanza di sedimenti che corrisponde all'incirca a 25 milioni di anni. Ciò permette di distinguere un Bugarone inferiore (di età Toarciano-Bajociano inferiore) ed un Bugarone superiore (di età Kimmeridgiano-Titoniano inferiore). Lo spessore della Formazione del Bugarone è ridotto a circa un quinto rispetto a quello della coeva successione “normale”.
Nel M. Nerone troviamo, dunque, elementi tali da far supporre ai geologi che, nel Giurassico, esso costituisse un alto strutturale. Troviamo, infatti, elementi che indicano una situazione simile a quella appena descritta. Però. Recentemente due laureande in scienze della Terra, L. Fournet e S Geroux dell'Institut Geologique Albert de Lapparent (I.G.A.L.) di Parigi, hanno misurato le direzioni di provenienza degli slumpings della valle del F. Bosso. Le loro indagini hanno permesso di concludere che gli slumpings non potevano avere origine dall'area del Nerone, anche se, in quel periodo, era un alto strutturale. Questa è una conclusione nuova ed interessante, ma da approfondire, che solleva molti altri problemi ed ipotesi risolutive.
Alla fine del Giurassico cominciò a depositarsi il Calcare Rupestre (o Maiolica) rappresentato da strati medio-piccoli di calcari bianco-grigiastri talvolta con selce scura. Questa formazione rocciosa, che troviamo distribuita dalla Lombardia fino alla Sicilia, ha uno spessore abbastanza uniforme. Ciò significa che la profondità del mare doveva essere più o meno uguale dappertutto. Talvolta tuttavia si possono trovare ancora degli slumpings o anche delle intercalazioni detritiche che testimoniano la permanenza di alti strutturali.
Nel Cretacico medio terminò la deposizione del Calcare Rupestre.
In questo intervallo del tempo geologico troviamo, infatti, condizioni ambientali del tutto nuove che hanno portato al deposito delle Marne a Fucoidi. Queste marne, oltre che dalla loro natura litologica, sono caratterizzate da svariati colori; spesso sono bituminose in quanto ricche di materia organica. Tutto ciò è la testimonianza di ambienti con acque povere di ossigeno e cioè di bacini marini con caratteristiche euxiniche o anossiche. In questi ambienti mancano i batteri aerobici i quali, tramite l'ossigeno, traggono l'energia necessaria per le loro funzioni vitali dalle reazioni chimiche di ossidazione della materia organica. Erano presenti, invece, i batteri anaerobici che, attraverso altri tipi di reazioni chimiche, trasformarono la materia organica in bitume. L'ambiente delle Marne a Fucoidi ebbe termine verso la fine dell’Albiano quando s'instaurò il mare della Scaglia durato fino alla fine dell’Oligocene.
La Scaglia ha uno spessore abbastanza elevato ed è caratterizzata da una variazione verticale dei colori e della composizione per cui, procedendo stratigraficamente verso l'alto, aumenta il contenuto argilloso e si passa da calcari bianchi a marne argillose cineree.
La Scaglia Bianca, parte inferiore dell'intera formazione rocciosa, è costituita da calcari bianchi, ben stratificati, che contengono spesso lenti o noduli di selce nera. Mediamente ha uno spessore di 60 m. Negli strati calcarei della Scaglia Bianca si trovano molti tipi di foraminiferi che tendono però a ridursi a mano a mano che ci si avvicina al suo limite superiore fino a scomparire un po' prima di raggiungerlo.
Al di sotto della Scaglia Bianca sta la Formazione delle Marne a Fucoidi che termina con uno straterello grigio-verdastro; al di sopra è situato invece il secondo membro della Scaglia, questa volta di colore rosato o rosso e perciò detto Scaglia Rossa.
Un criterio di suddivisione di questi due membri della Scaglia è dato non solo dal colore rosso degli strati calcarei, ma anche dal colore rosso della selce; può succedere, tuttavia, che il colore rosso tagli obliquamente gli strati per uno spessore di alcuni metri e a volte raggiunga anche un bancone nerastro, d'aspetto argilloso, al quale è stato dato il nome di Livello Bonarelli.
La composizione litologica del Livello Bonarelli è abbastanza varia: si possono osservare straterelli calcarei, argillosi, arenaceo-argillosi e talvolta noduli fosfatici. Predomina il colore nero, accompagnato anche dal giallastro. Nelle Marche il Livello Bonarelli non ha uno spessore costante: questo varia tra 45 cm e 2 m. I fossili più caratteristici sono i pesci che purtroppo non sono spesso conservati interi, ma essi hanno permesso di riferire il Livello Bonarelli alla parte superiore del Cenomaniano. Per questo motivo il Livello Bonarelli è diventato un indicatore preciso di questa età a livello regionale o, come dicono i geologi, un “marker stratigrafico”.
Nel Livello Bonarelli, oltre ai resti di pesci, si possono osservare molti radiolari, microfossili caratterizzati dal loro guscio siliceo di forme svariatissime. Un'altra interessante componente è rappresentata dalle sostanze bituminose. Il livello Bonarelli ne è così ricco che si pensò di poterne estrarre degli idrocarburi ed anche l'ittiolo, ma la spesa era superiore al probabile ricavo.
Questo Livello ha dunque aspetti molto interessanti. Che cosa rappresenta?
La presenza di idrocarburi e di bitume sembra indicare un processo sedimentario in un ambiente privo di ossigeno (anossico). Attualmente troviamo condizioni di anossia nei fondali del Mar Nero in cui le acque profonde sono prive di circolazione, immobili. Per questo motivo la concentrazione d'ossigeno in tali acque è zero. Esse sono invece abbastanza ricche di idrogeno solforato. Mancanza d'ossigeno e presenza di idrogeno solforato impediscono la vita a qualsiasi organismo. Ad una certa profondità il Mar Nero è dunque un vero e proprio deserto biologico. In realtà alcuni batteri possono vivere in queste condizioni estreme: sono i batteri anaerobici. Questi sono stati ritrovati anche in vicinanza di sorgenti termali sottomarine che fuoriescono a grandi profondità negli oceani oppure nei fanghi di paludi salmastre, negli stagni o nelle lagune vicine a fumarole. I batteri anaerobici eliminano a poco a poco l'ossigeno e l'idrogeno dai corpi degli organismi che cadono sul fondo o che comunque vengano a trovarsi in un ambiente privo di ossigeno. Questi processi determinano un progressivo arricchimento in carbonio e la trasformazione dei grassi e delle proteine degli organismi morti in idrocarburi e dunque in bitume.
Il Livello Bonarelli è stato definito recentemente come un “evento anossico oceanico” in quanto presente in tutti gli oceani dell'epoca. Esso è stato messo in relazione con lo sviluppo della dorsale atlantica che provocò un aumento di emanazioni vulcaniche e flussi di calore ed inoltre un innalzamento del livello marino. Come conseguenza si ebbe il riscaldamento delle acque oceaniche, variazioni nella loro circolazione e un abbattimento della concentrazione di ossigeno per cui sui fondali marini si formò un vero e proprio deserto biologico. La materia organica che si depositava dava origine a grandi depositi dai quali, per opera di batteri anaerobici, si sviluppò poi il bitume.
Con la Scaglia Variegata e con quella Cinerea termina la successione della Scaglia.
La Scaglia Variegata è costituita da marne e marne calcaree policrome. Ha uno spessore variabile da 5 a 30 m.
La Cinerea è costituita da marne (da calcaree ad argillose) di colore cenere o grigioverdastro, talora giallastre. È più calcarea nella parte inferiore, più argillosa nella superiore. Lo spessore varia da 90 a 200 m. La Variegata e la Cinerea hanno strati generalmente piccoli, interessati da piccole fratture che conferiscono ad essi un aspetto veramente scaglioso.
Il Bisciaro e lo Schlier, giacciono, nell’ordine, sopra la Scaglia Cinerea. La Formazione del Bisciaro è costituita da più litotipi rappresentati: da calcari marnosi di colore marrone scuro; da calcari selciferi di colore grigio giallastro, spesso con la selce in lenti o in noduli; da marne grigio azzurrognole, in strati medi o grossi, più calcaree alla base e più argillose alla sommità della formazione. Lo spessore complessivo del Bisciaro può variare da 30 a 70 m, ma ciò dipende spesso da faglie o ripiegature degli strati.
Lo Schlier è costituito da marne-argillose o argille-marnose di color grigioazzurrognolo, in grossi strati o in banchi fra i quali sono interposti calcari marnosi di colore grigio o giallastro-verdognolo in strati piccoli. La parte più recente di questa formazione rocciosa è quella più argillosa.
Lo Schlier è un indicatore del cambiamento della paleogeografia nel dominio appenninico-adriatico. Le prime spinte orogenetiche cominciavano infatti a fare emergere la catena umbro-marchigiana. Questo nuovo evento si prolungò per tutto il Miocene, ossia per un periodo di tempo compreso tra 23 e 5 milioni di anni fa.
Poco dopo l'inizio del Miocene, il bacino umbro-marchigiano fu suddiviso in due parti: il bacino umbro (più interno) e, ad oriente, il bacino marchigiano (più esterno).
Nel bacino umbro cominciò a depositarsi la Formazione Marnoso-Arenacea che raggiunge e a volte supera 2000 m di spessore; in quello marchigiano si depositò, invece, la Formazione dello Schlier che, a confronto con la prima, ha un modesto spessore. Schlier e Marnoso-Arenacea hanno più o meno la stessa età geologica, ma caratterizzano differenti bacini di deposizione e i loro rapporti sono abbastanza complessi. Il bacino marchigiano, successivamente, si divise in una porzione più interna e in un'altra più esterna (adriatica). La parte interna era smembrata in parecchi bacini minori situati tra varie dorsali. Nel bacino più settentrionale, al di sopra della Formazione Marnoso-Arenacea, si depositarono le Arenarie e Marne di M.Vicino, una formazione composta da due membri marnoso-argillosi fra i quali è interposto un membro arenaceo.
La Formazione di M. Vicino affiora ampiamente nella valle del F. Bosso, subito ad ovest di Pianello.
Nel gruppo montuoso del Nerone mancano le formazioni che caratterizzano la parte più recente del Miocene e del Pliocene.
I depositi d'origine più recente, d'età pleistocenica ed olocenica, sono i detriti di falda e le alluvioni.
Il detrito di falda è rappresentato da frammenti rocciosi deposti alle pendici dei versanti. Questi elementi sono generalmente grossi, possono essere cementati oppure sciolti e provengono dalle varie formazioni che localmente costituiscono il substrato roccioso. La forma di tali elementi è molto variabile: va dalla lamina al poliedro. In generale presentano spigoli vivi, angolosi. Nelle scarpate naturali o artificiali gli elementi detritici possono essere facilmente rimossi dalla loro sede a causa dei processi di gelo-disgelo durante il periodo invernale. I detriti di falda sono grossolanamente stratificati. Lo spessore varia da pochi metri a qualche decina di metri. Questi depositi presentano un'alta permeabilità.
Le alluvioni sono accumuli detritici, deposti dai corsi d’acqua, che ricoprono in discordanza le formazioni del substrato roccioso. Hanno una potenza ed un'estensione molto variabili. La composizione granulometrica di queste coltri alluvionali è eterogenea sia verticalmente, sia orizzontalmente. Si passa spesso rapidamente da ghiaie ad elementi grossolani ad altre ad elementi minuti con strutture più o meno embricate o piano-parallele, a lenti sabbiose o a depositi di limo e argilla. Gli elementi che costituiscono le ghiaie provengono dalle formazioni litologiche presenti nel bacino idrografico: per lo più sono frammenti di calcari o marne con un grado di sfericità molto variabile e con un arrotondamento che va da subangoloso ad arrotondato. Il colore della matrice, ossia della porzione più fine delle ghiaie, varia da marrone, più o meno scuro, nella parte più alta della coltre detritica a rossastro nella parte sottostante.
Chiudiamo questo capitolo con una nota sui nomi della formazioni rocciose. Còrniola, Marmarone e Bisciaro sono forse quelli che sollevano più domande.
La mia ipotesi è che Còrniola debba il suo nome al colore carnicino (carneus) della parte più alta della formazione rocciosa.
Marmarone rivela la sua origine dal latino "marmor" o meglio ancora dal greco "marmaros", entrambi dal termine indoeuropeo "marnasthai".
Sembrerebbe di avere individuato anche l'origine di "marna" che è fatta risalire però al francese "marne" e questo al latino parlato "margila" proveniente dal vocabolo gallico "marga" (così ho trovato nello "Zingarelli"). Anche dai nomi delle rocce s'impara qualcosa.
Bisciaro con le bisce non dovrebbe aver proprio alcuna relazione. Il Bisciaro si nota molto bene nel paesaggio agricolo: è sempre ricoperto dal bosco. È una formazione rocciosa inadatta ai seminativi e quindi una roccia "bastarda", termine che ho sentito usare da cavatori e che nel dialetto umbro è "biscia".
Orogenesi appenninica
Il sollevamento della catena appenninica si è realizzato in più tempi procedendo dal M. Tirreno verso l'Adriatico, ossia da ovest verso est. Questa affermazione è confermata dalla successione dei depositi sedimentari che sono sempre più giovani procedendo in questo senso. Dallo studio dei fenomeni sismici è anche possibile comprendere che le deformazioni che avvengono oggi nella catena appenninica hanno origine da processi di tipo distensivo (ossia che allungano il territorio), mentre nell'avanfossa adriatica sono di tipo compressivo (accorciano il territorio).
Possiamo distinguere tre grandi domini strutturali: il dominio tosco-tirrenico, che sta estendendosi a causa di un assottigliamento della
crosta terrestre (in quest'area i flussi di calore che provengono dall'interno sono elevati);
il dominio della catena appenninica, sollevata durante il Miocene-Pliocene;
il dominio dell'avanfossa adriatica, deformata da strutture compressive di età Pliocene-Pleistocene ed ancora attive.
Al contrario di quanto avviene nel primo dominio, in quello della catena e dell'avanfossa il flusso di calore ha bassi valori. L'interpretazione di dati geofisici (sismici, magnetici e gravimetrici) ha permesso di riconoscere delle superfici immergenti verso ovest, che interessano la copertura sedimentaria e il suo basamento, lungo le quali si ritiene che avvenga un accavallamento della crosta tosco-tirrenica su quella adriatica. Per spiegare l'evoluzione della catena appenninica, la maggior parte dei geologi, che si dedicano agli studi di geodinamica, hanno adottato l’ipotesi della collisione di grandi masse terrestri, dette placche o zolle continentali, e della loro subduzione. Si ha subduzione, ad esempio, quando della crosta oceanica è costretta a scorrere al di sotto di una placca continentale.
Nel caso della nostra regione al di sotto della copertura sedimentaria è stato individuato un basamento di rocce prevalentemente metamorfiche, in cui si distingue una parte superiore che deriverebbe dalla crosta tosco-marchigiana ed una inferiore dalla crosta adriatica. Lo studio delle formazioni rocciose e l'interpretazione dei dati raccolti mediante varie metodologie d'indagine geofisica hanno permesso, inoltre, di evidenziare l'esistenza di diversi scollamenti tra le formazioni rocciose ed il basamento. Lo scollamento più marcato corrisponde alle Anidriti di Burano. Questi scollamenti, che con termini più rigorosi possiamo chiamare faglie inverse, sovrascorrimenti, ma anche retroscorrimenti, hanno determinato la sovrapposizione, più o meno accentuata, delle anticlinali sulle sinclinali. Gli assi delle grandi pieghe anticlinali sono subparalleli ai sovrascorrimenti. La sommità di tali pieghe è piuttosto appiattita; il loro fianco orientale, al contrario di quello occidentale, è subverticale, ma può anche essere rovesciato al di sopra delle formazioni rocciose che lo precedono e che costituiscono delle sinclinali. Tali sinclinali appaiono molto strizzate, fenomeno di cui i geologi si erano accorti da tempo.
Nel 1954, grazie alle perforazioni per le ricerche del petrolio condotte nella gola del F. Burano, era stato possibile scoprire che, al di sotto del Calcare Massiccio, esiste un'altra formazione rocciosa denominata Anidriti di Burano. Questa è costituita da dolomie, anidriti e gessi che probabilmente furono deposti in un ambiente di lagune e piane costiere. Il ritrovamento delle Anidriti del F. Burano è stato molto importante per la comprensione dei vari fenomeni relativi alla struttura tettonica dell'Appennino marchigiano.
La storia dell'Appennino umbro-marchigiano inizia nel Triassico medio quando esisteva un unico grande continente chiamato Pangea. Ruscelli, torrenti, ghiacciai e venti modellavano la sua superficie; ciottoli, sabbia e fango prodotti dalla loro azione erosiva, erano poi trasportati dai fiumi fino alla loro foce e quindi al mare. Successivamente il mare cominciò ad avanzare sulla terraferma e in questa trasgressione gli accumuli detritici furono rimaneggiati e rielaborati cosicché ebbe origine una nuova formazione rocciosa alla quale i geologici danno oggi il nome di Verrucano. Gessi e calcari si accumularono al di sopra del Verrucano per oltre 1000 m di spessore ed essi sono la testimonianza di un clima caldo per cui evaporavano facilmente le acque da bacini più o meno chiusi lasciando depositare invece i sali che avevano disciolto. Le Anidriti di Burano, che non affiorano nelle Marche, sono a loro volta ricoperte dai Calcari e Marne a Rhaetavicula contorta, che più o meno segnano il passaggio dal Triassico al Giurassico, o meglio al Lias. Le coste di Pangea erano orlate da grandi barriere coralline; il loro insieme costituiva un'estesa piattaforma marina composta prevalentemente da sostanze minerali carbonatiche. Da queste ebbe poi origine il Calcare Massiccio. Nel Lias inferiore questa piattaforma fu spezzata in parecchi blocchi cosicché il rilievo sottomarino presentava profondi bacini dove i blocchi erano sprofondati e dorsali montuose dove invece l'annegamento risultò attenuato. Alcuni blocchi probabilmente emersero.
Che cosa stava avvenendo?
Secondo una ipotesi geologica, attualmente dominante, esisteva un unico, grande continente, denominato Pangea, circondato da un grandissimo oceano chiamato Pantalassa. Sul bordo orientale di Pangea esisteva un grandissimo golfo marino che i geologi chiamano Tetide. La parte più interna del golfo corrispondeva all'incirca a Gibilterra. In posizione diametralmente opposta, Pangea si stava spaccando con grandi linee di frattura in senso ovest-est. Era l'inizio dell'Oceano Atlantico centrale che s'incuneava tra due parti di Pangea, ossia Laurasia a nord e Gondwana a sud, i due nuovi continenti che derivarono dalla divisione di Pangea. Questi eventi, che potrebbero sembrare catastrofi rapidissime, avvenivano in realtà molto lentamente. La storia della Terra s'estende per un lungo arco di tempo e le "catastrofi" non sono mai state più disastrose di quelle che accadono oggi: eruzioni vulcaniche, terremoti, frane. Piccoli effetti accumulati possono, però, alla fine di un lungo periodo di tempo, produrre un risultato straordinario. Secondo l’ipotesi della tettonica delle placche, a far spostare le masse continentali sarebbero delle celle di convezione del calore che agiscono sotto la crosta terrestre. Il calore provocherebbe una dilatazione ed un assottigliamento della crosta terrestre fino a determinarne la rottura. Nel Lias inferiore, una penisola si prolungava nella Tetide da quella che possiamo considerare l'Africa attuale. Tale penisola è chiamata Adria, Ad ovest e a nord di Adria era situata Laurasia, comprendente le terre che, oggi, rappresentano le aree mediterranee di Spagna, Francia, Sardegna e Corsica: tutte queste, saldate fra loro, sono indicate dai geologi come Iberia.
Nelle formazioni di origine sedimentaria dell'Appennino settentrionale si trovano delle ofioliti che sono, invece, rocce di origine magmatica. Queste ofioliti, tuttavia, non hanno un collegamento con un apparato magmatico, sembrano senza radici. Più precisamente si ritiene che le ofioliti derivino da un magma che, attraverso delle fratture, fuoriusciva da un fondale oceanico in espansione. Per complessi eventi geodinamici le ofioliti sono finite in mezzo alle rocce sedimentarie. Se veramente queste rocce sono la testimonianza di un fondo oceanico, ciò significa che doveva esistere un oceano tra Adria ed Iberia. Questo oceano è stato chiamato "oceano ligure-piemontese". Contemporaneamente, l’evoluzione dell'Atlantico doveva provocare la rotazione dell'Africa che ha avuto, come conseguenza, lo scontro di Adria con il margine del continente euro-asiatico. Tutto ciò produsse, ad un certo punto, anche la separazione di Adria dall'Africa. Adria è il basamento profondo sul quale poggia il nostro Appennino e le loro storie, dunque, s’identificano. La frammentazione della piattaforma carbonatica, rappresentata dal Calcare Massiccio, è la conseguenza di questi eventi. Grandi blocchi sprofondati diedero origine a bacini marini, mentre altri mantennero più o meno la stessa posizione o anche emersero e sono i cosiddetti alti strutturali. Alcuni geologi ritengono che il dislivello tra gli alti strutturali ed i fondali marini non superasse qualche decina o forse un centinaio di metri, altri invece pensano che il dislivello fosse maggiore. Tralasciando queste considerazioni, noi oggi possiamo riconoscere le formazioni rocciose che si formarono in un ambiente di bacino, oppure su un alto strutturale perché le condizioni biologiche e chimico-fisiche che caratterizzavano questi ambienti erano molto diverse.
Si è già detto di una lacuna di sedimentazione nella Formazione del Bugarone messa in evidenza dalla mancanza di livelli ad Ammoniti. Tale lacuna corrisponde ad un intervallo temporale compresso tra il Bajociano e l'Oxfordiano, ossia da 167 e 145 milioni d’anni fa. Secondo recenti studi questa pausa rappresenta un periodo di stasi della subsidenza che era stata invece intensa dal Lias medio al Bajociano. La subsidenza dei fondali riprenderà ad aumentare dal Giurassico superiore fino alla fine del Cretacico inferiore quando s'incontra un'altra grande lacuna, durata circa 13 milioni di anni, corrispondente all'intervallo Berriasiano-Valanginiano. Nel Cretacico superiore, nell'arco di tempo corrispondente al deposito delle Marne a Fucoidi e di parte della Scaglia, la subsidenza ritornò ad accentuarsi, particolarmente nelle aree coincidenti con i precedenti bacini del Giurassico. Nel Calcare Rupestre e nella Scaglia si trovano infatti ancora degli slumpings che sono la testimonianza dell'esistenza di alti strutturali e di bacini contigui. Solo nell'Eocene, ossia 50 milioni d’anni fa, queste differenze nel rilievo sottomarino sembrano scomparire completamente. L'oceano ligure-piemontese terminò di esistere nell’Eocene superiore. A causa delle spinte prodotte dallo spostamento dell’Africa, la crosta oceanica, che si era formata sul fondo dell’Oceano ligure-piemontese, e una parte dei sedimenti che si erano deposti al di sopra, cominciarono ad essere trascinati per subduzione sotto il continente euro-asiatico, ossia Laurasia. Un’altra parte, invece, di quei sedimenti, sotto forma di grandi scaglie tettoniche, si sovrapposero fra loro al di sopra della zona di subduzione e costruirono un enorme accumulo, ossia un prisma di accrezione. I sedimenti di questo prisma sono stati chiamati unità liguri e nel tempo, sempre più frammentate o caotiche, furono traslate verso Est. Una parte di esse formano oggi la struttura principale del M. Carpegna. Nell’Oligocene superiore, in corrispondenza della zona di collisione tra Iberia ed Adria, si formarono varie fosse tettoniche. Queste indicate come bacino del Macigno, bacino delle Arenarie del M. Cervarola e bacino della Marnoso-Arenacea compaiono successivamente nel tempo procedendo da ovest verso est e, dunque, con un orientamento ben definito. Dai sedimenti deposti in questi bacini hanno avuto origine le dorsali montuose della Liguria, della Toscana, dell'Emilia e dell'Umbria che nel loro insieme formano l'Appennino settentrionale. Ciò avvenne non solo con una successione temporale che potremmo dire cadenzata, ma anche con un orientamento ben preciso in senso SW-NE. In questo lungo periodo di tempo l'area umbro-marchigiana pare che si mantenesse relativamente tranquilla. Arrivò però il suo momento e anche l’Appennino umbromarchigiano cominciò ad emergere sotto l’azione delle forze compressive che deformarono, piegarono e spezzarono le sue formazioni rocciose. Durante il Miocene, il dominio umbro-marchigiano si trasformò in una fossa tettonica in cui sono stati riconosciuti più bacini: l'umbro-romagnolo, il marchigiano interno e il marchigiano esterno separati rispettivamente dalle dorsali umbro-marchigiana (catena del Catria) e marchigiana (catena dei monti del Furlo). In questi bacini si deposero le torbiditi che hanno ricoperto la formazione dello Schlier.
Nel bacino umbro-romagnolo si depositò invece la Formazione Marnoso-Arenacea. Continuò dunque quella caratteristica migrazione dei bacini da occidente ad oriente, ossia verso il Mare Adriatico, che era iniziata in precedenza. Gran parte delle formazioni rocciose che si formarono in tali bacini sono rappresentate da torbiditi. Nel Bacino Marchigiano interno e in quello Esterno, dal Tortoniano in poi, si ebbero infatti parecchi piccoli bacini caratterizzati da una grande variabilità di litotipi. Si tratta del bacino di M. Vicino (quello più interno) in cui si depositarono marne e arenarie; del bacino di Pietrarubbia - Peglio - Urbania; del bacino di Montecalvo in Foglia e del bacino di Monteluro; un po’ più a sud ne troviamo altri ancora. Nel Messiniano tutta l'area mediterranea attraversò un periodo d'aridità, conosciuto come “crisi di salinità”, durante il quale il livello marino subì un forte abbassamento. In varie parti s’instaurarono ambienti salmastri ove si depositò la Formazione gessoso-solfifera.
Nel successivo Pliocene il mare ritornò ad occupare le aree che aveva abbandonato durante la crisi di salinità. In questo periodo, tuttavia, gli eventi tettonici furono particolarmente frequenti e potenti tanto da completare il corrugamento di tutto il bacino umbro-marchigiano. Dopo una breve pausa, nel successivo Pleistocene un'altra intensa fase tettonica, caratterizzata da faglie verticali, portò la catena appenninica al suo assetto definitivo.
Le acque del Bosso
A circa 7 Km da Cagli, nella gola del Bosso, a livello del corso d’acqua c'è la sorgente più famosa della valle: il Bagno di S. Nicolò, le cui acque hanno proprietà curative. Secondo Selli (1954) questa è una sorgente di trabocco da anticlinale per sbarramento sui fianchi che ha come roccia serbatoio il "Calcare Massiccio" e la "Còrniola" e come battente impermeabile il "Rosso Ammonitico". La portata, misurata da Perrone nel 1910, è di 5 l/sec . Questa sorgente non viene esaminata nei lavori di Selli (1961) e di Neviani (1961), ma nuovi studi sulle caratteristiche delle acque sono stati intrapresi per valutarne le possibilità di utilizzo per usi potabili. Parecchi anni fa l'Istituto di Idrologia dell'Università degli Studi di Pavia effettuò un'analisi chimica delle acque di S. Nicolò. Da tale analisi risulta che la composizione ionica delle acque del Bagno di S. Nicolò è dovuta prevalentemente a solfati di calcio e magnesio che rappresentano circa l'85% dei sali disciolti. L'elevata durezza, pari ad 88°gradi francesi (°F), ed il contenuto in solfati rendono queste acque di scarsa qualità ed inutilizzabili per scopi potabili perché "se i solfati superano la concentrazione di 250 mg/l e compaiono insieme a magnesio e sodio possono provocare irritazioni gastro-intestinali in quanto che i solfati di sodio e di magnesio hanno azione purgativa".
Dalle analisi chimiche risulta che le due sorgenti (che costituiscono il Bagno di S. Nicolò) hanno rispettivamente i seguenti tenori di ioni metallici e dello ione solforico, espressi in mg/l:
Na+ ..........1,5...... 1,2
Ca++.....250,0... 252,0
Mg++..... 62,6..... 62,6
SO4- -... 695,0... 700,0
Dalle indagini svolte dal Consorzio Idrico dell'Alto Metauro risulta invece che la portata dei Bagni di S. Nicolò è di 110 l/sec, ciò che contrasta nettamente con le indicazioni di Perrone e di Selli. Tempo fa il Consorzio Idrico dell'Alto Metauro chiese di immettere tali acque nel proprio acquedotto. Si riuscì ad evitare tutto ciò perché il Comune di Cagli aveva progettato di utilizzarle in altro modo e cioè in terme ove si potesse curare certe malattie della pelle. Per fortuna poi non se ne fece nulla. Tralasciando ulteriori considerazioni sulle acque di S. Nicolò, ciò che interessa da un punto di vista geologico-ambientale è l'eccezionale presenza di questa sorgente nel bacino del F. Bosso perché il chimismo di queste acque è nettamente diverso da quello delle sorgenti vicine.
Acque con un chimismo analogo sono note nel bacino del F. Metauro connesse con la Formazione "Gessoso-Solfifera" che però manca nel bacino del F. Bosso; sorgenti di acque solfuree, che potrebbero essere ossidate a solfate, sono invece note nelle formazioni calcaree mesozoiche ("Còrniola" e "Maiolica"), spesso ricche di pirite e di marcasite. È tuttavia possibile ipotizzare anche una loro derivazione dalla Formazione delle Anidriti del F. Burano che stanno al di sotto del "Calcare Massiccio". Questa ipotesi è stata proposta recentemente da Nanni & Vivalda (1999) i quali ritengono che le acque della sorgente di S. Nicolò per "la costanza della temperatura (16°C) e il particolare chimismo con arricchimenti in solfati, calcio e magnesio, indicano la venuta a giorno di acque caratterizzate da una circolazione profonda che ha interessato o la porzione basale del Calcare Massiccio fortemente mineralizzata per lisciviazione delle Anidriti di Burano o le stesse Anidriti triassiche". Anche se le conoscenze geologiche ed idrogeologiche sono ancora insufficienti per una definitiva soluzione della questione, ciò tuttavia non sminuisce l'interesse scientifico-naturalistico per le acque della sorgente di San Nicolò che si riversano, con il loro bel colore dai riflessi azzurri, in quelle del F. Bosso.
Le acque del F. Bosso provengono dalle sorgenti presenti nel bacino e dalle precipitazioni atmosferiche. Le sorgenti sono connesse alla permeabilità delle rocce e cioè alla capacità di lasciarsi attraversare dall'acqua. Ciò può dipendere dalla porosità oppure dal grado di fessurazione della roccia stessa. Affinché una roccia sia permeabile è necessario che i pori o le fratture siano in comunicazione tra loro: nel primo caso si parla di permeabilità primaria, nell'altro di permeabilità secondaria.
Dal punto di vista della permeabilità le formazioni rocciose del bacino del F. Bosso possono essere suddivise nel seguente modo:
a permeabilità elevata
- Calcare Massiccio
- Còrniola
- Calcare Rupestre o Maiolica
a permeabilità media
- Formazione del Bugarone
- Scaglia bianca e rosata
a permeabilità bassa
- Calcari diasprini
- Bisciaro
- Formazione marnoso-arenacea
- Arenarie di M. Vicino
a permeabilità molto bassa
- Marne a Fucoidi
- Scaglia variegata e cinerea
- Schlier
a permeabilità variabile
- Detriti di falda
- Alluvioni fluviali
L'alternarsi di formazioni rocciose permeabili ed impermeabili è la condizione che permette l'accumulo delle acque d'infiltrazione. Infatti, le formazioni impermeabili, più o meno continue, non lasciano passare le acque che si sono infiltrate nelle formazioni permeabili. Si forma così una falda acquifera che si raccoglie nella roccia permeabile. Se la falda acquifera interseca la superficie topografica essa allora emerge sotto forma di sorgente. Nel massiccio del Nerone e del Petrano predominano le formazioni calcaree che, come si è detto, hanno in generale spessori elevati. Un primo orizzonte acquifero è rappresentato dal Calcare Rupestre (o Maiolica) che sta al di sopra dei Calcari Diasprini, una formazione poco permeabile. In questo caso si hanno sorgenti di trabocco. L'altro grande acquifero del M. Nerone è rappresentato dal Calcare Massiccio al quale possiamo unire le sovrastanti formazioni della Còrniola e del Bugarone. La permeabilità di questo complesso calcareo è secondaria, ossia è connessa al grado di fessurazione della roccia e ai fenomeni carsici. In questo caso le sorgenti non dipendono dalla presenza di un substrato impermeabile (eccettuando alcuni casi), ma dalle fratture che rappresentano la via di fuoriuscita dell'acqua sotterranea (sorgenti di fessura). Le fratture, dunque, sono la via d'accesso, ma anche d'uscita dell'acqua raccolta nei massicci calcarei. Sappiamo con certezza che l'acqua che esce attraverso le sorgenti è solo una piccola parte di quella conservata all'interno.
Il bacino idrografico del F. Bosso ha un'estensione di circa 126 Kmq ed appartiene ai comuni di Cagli, Cantiano e Pietralunga. Il suo spartiacque ha per caposaldi il M. Cimaio (1249 m s.l.m.), la Montagnola (1486 m), M. Nerone (1525 m), M. Cerrone (874 m), Pian delle Serre (1020 m), M. Petrano (1162 m) per chiudersi ad est dell'abitato di Cagli alla confluenza con il F. Burano (all'incirca a 250 m s.l.m.). L'altitudine media è 677 m . L'asta principale ha origine dal M. Castellaccio ed ha una lunghezza di circa 26,8 Km. La parte permeabile del bacino rappresenta il 36% della sua superficie. Le acque che cadono nel punto estremo del bacino impiegano, più o meno, 4 ore (tempo di corrivazione) per raggiungere la confluenza a Cagli con il F. Burano. Gli affluenti del F. Bosso disegnano un reticolato sviluppato in tutte le direzioni (drenaggio dendritico) che fa capo tuttavia al collettore principale. Questo modello è più caratteristico della parte sudoccidentale del bacino, ossia in corrispondenza del substrato prevalentemente marnoso-arenaceo. In media riceve 1300 mm di pioggia all'anno.
A Cagli la media annua delle precipitazioni è uguale a 1279 mm e la più alta media mensile è quella di Novembre con 154 mm; a Cantiano la media annua è 1256 mm e la più alta media mensile è quella di Novembre con 153 mm . Il periodo delle massime precipitazioni coincide con quello autunnale e in particolare con Novembre che è il mese più ricco di piogge, ma esse possono essere abbondanti anche nei mesi di febbraio e marzo.
Massimo mensile..... Massimo annuale
Cantiano 406.................. 2018
Pianello.. 367................. 1844
Le curve cumulative delle altezze di precipitazioni mensili mettono in evidenza le analogie esistenti fra le precipitazioni a Cagli, Cantiano e Pianello. I valori, in mm, delle altezze di precipitazioni mensili minori o uguali al 25%, al 50%, al 75% o al 90% sono riportate nella seguente tabella.
Precipitazioni mensili..... Cantiano Cagli Pianello
25%................................. 46....... 56..... 56
50%................................. 90....... 94..... 94
75%............................... 134...... 144... 144
90%............................... 191...... 188... 196
Da questi risultati si ricava che il 10% delle precipitazioni mensili ha un valore superiore a 188 mm. Siccome il 10% di 12 mesi è 1,2 mesi, ciò significa che almeno in un mese dell'anno piove più di 188 mm. Le maggiori altezze di precipitazioni sono più probabili nel periodo settembre-dicembre, ma anche nel periodo febbraio-marzo sono possibili abbondanti precipitazioni. In particolare novembre è il mese più ricco di piogge.
Le medie delle precipitazioni mensili, calcolate per un cinquantennio, sono riportate nella tabella seguente.
..................Cantiano Pianello
Gennaio......... 114..... 117
Febbraio........ 123..... 124
Marzo............ 111..... 114
Aprile............ 104..... 105
Maggio.......... 100...... 102
Giugno............ 70....... 75
Luglio............. 49....... 49
Agosto........... 65....... 63
Settembre...... 94..... 103
Ottobre........ 130..... 143
Novembre..... 153.... 165
Dicembre...... 143.... 154
Anno............ 1256... 1314
Per quanto concerne il periodo estivo, con i dati meteorologici disponibili (periodo 1921-1971) si ottiene che 8 mesi estivi su 100 hanno un'altezza di precipitazioni inferiore a 10 mm e 25 mesi estivi su 100 hanno un'altezza di precipitazioni inferiore a 30 mm (mesi siccitosi). In 3 mesi estivi ogni 100 non piove affatto (1 mese ogni 11 anni), ma 20 mesi estivi ogni 100 hanno precipitazioni inferiori a 2 mm (1 mese ogni 2 anni) e 39 mesi estivi su 100 hanno precipitazioni inferiori a 4 mm (1 mese ogni anno).
Le precipitazioni nevose possono essere espresse mediante alcuni valori o coefficienti. Per una determinata località il coefficiente nivometrico è dato dal rapporto percentuale fra la quantità d'acqua (espressa in mm) caduta sotto forma di neve e la quantità totale di precipitazioni.
Una stima del coefficiente nivometrico (K%) per il bacino del F. Bosso in relazione all'altitudine può essere ricavata dalle corrispondenti formule relative all'Appennino settentrionale e all'Appennino abruzzese (Gazzolo, 1973), ossia per l'Appennino settentrionale (versante adriatico) K% = 0,9 h + 3,1 e per l'Appennino abruzzese K% = 1,7 h – 1,0 in cui h è l'altitudine espressa in ettometri.
Si può stimare che circa un quinto delle precipitazioni che cadono ad un'altitudine superiore a 1300 m abbiano carattere nevoso. La durata del manto nevoso (D), che è in stretta correlazione con le condizioni termiche delle località, può essere stimata con la seguente formula (Pinna,1973) valida per il versante adriatico dell'Appennino centrale D = 7,9 h – 26,2 in cui h è espresso in ettometri e D in giorni. L'altezza della neve fresca si può ottenere mediante le seguenti formule (Gazzolo, 1973) valide rispettivamente per il versante adriatico dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino abruzzese: N = 17,4 h + 16,1 N = 12,9 h + 18,1 in cui N è il totale annuo della neve fresca in cm ed h è l'altitudine in ettometri. Da queste stime si ricava che sul M. Nerone ad un'altitudine di circa 1300 m s.l.m. il 20% delle precipitazioni ha carattere nevoso, pari a circa 220 cm di neve fresca la cui durata sul terreno è uguale a 77 giorni.
In base a registrazioni anemografiche relative alle punte massime giornaliere della velocità del vento a M. Nerone (1526 m s.l.m.) nel periodo 1968-1979 si rileva che in ogni mese dell'anno le raffiche di vento possono raggiungere 120 Km/h con massime di 165-185 Km/h nel mese di novembre.
I profili pluviometrici indicano che il regime è di transizione fra quello mediterraneo e quello continentale. Risaltano una stagione piovosa autunnale con discrete precipitazioni ed una stagione estiva abbastanza secca ed inoltre un massimo secondario di precipitazioni a Febbraio ed un minimo secondario a Gennaio. Il gruppo montuoso del Nerone è un efficace regolatore della distribuzione delle piogge: quelle sul versante sud-occidentale sono più abbondanti rispetto a quelle sul versante nord-orientale.
Non sono noti i coefficienti di deflusso relativi al F. Bosso. Nella tabella seguente sono riportati i minimi coefficienti di deflusso del F. Candigliano di cui il Bosso è affluente, registrati nella stazione di Acqualagna durante il trimestre luglio-agosto-settembre.
Settembre 1971...... 0,03
Agosto 1973........... 0,05
Settembre 1970...... 0,06
Agosto 1970........... 0,07
Luglio 1970............. 0,09
Le medie dei coefficienti di deflusso del periodo 1924-1930; 1932-1933; 1959; 1962-1965; 1967-1973 per i mesi di luglio-agosto-settembre sono riportate nella tabella seguente.
Luglio......... 0,24
Agosto....... 0,16
Settembre.. 0,16
Alcune misurazioni di portate (settembre-ottobre 1985), mediante due stramazzi costruiti uno in località Eremita ed un altro poco a monte dei Bagni di S. Nicolò, hanno fornito i seguenti valori espressi in l/sec:
...........................Eremita....... Bagno S. Nicolò
28/9/1985.............. 21,3................ 72,4
29/9/1985............... 17,7 ..................=
9/10/1985............... 22,5................ 69,0
16/10/1985.............. 29,9................ 63,7
Il valore medio delle portate relative a questo periodo è stato di 68,5 l/sec al Bagno S. Nicolò. Probabilmente nell'estate 1985 le portate del F. Bosso pari a 20-30 l/sec all'Eremita e a 65-70 l/sec a monte del Bagno S. Nicolò, tenuto conto del lungo periodo siccitoso di quell’anno, corrispondevano al solo contributo d'acqua delle sorgenti perenni e delle venute di subalveo. Più alti valori di portate del Bosso, riferite da Selli (1971), corrispondono ad una annata (1958) in cui le precipitazioni (1454 mm) sono state superiori alla media (1308 mm, media 1950-71).
Qualche anno fa presso il Comune di Cagli sono state effettuate giornalmente le misure di portata del F. Bosso a Pianello e a Cagli (località Passerella). Dai dati relativi al periodo maggio 1997 – aprile 1998 risulta che il 34% delle portate è inferiore a 1100 l/sec e il 50% delle portate è inferiore a 1500 l/sec.
L’Aula Bosso
Con l'analisi degli aspetti naturali ed antropici della valle del F. Bosso ho cercato di metterne in risalto le emergenze più significative. Queste, tuttavia, sono state oggetto per secoli di interventi di degradazione culminati, in tempi più recenti, con ampliamenti stradali e costruzioni di tralicci per le linee elettriche. Flora e vegetazione sono in un grave stato di conservazione come attestano le schede relative alle Aree Floristiche pubblicate dalla Regione Marche. Bisogna tener conto infine che, a causa dell'invecchiamento della popolazione residente, è venuto sempre più a mancare un reale rapporto con l'ambiente, con tradizioni e con esperienze umane e culturali. Sembra ovvia, dunque, la conclusione che occorre tutelare il patrimonio storico-ambientale, i centri abitati, le aree floristiche, le emergenze geologico-geomorfologiche della valle del F. Bosso.
Per questi motivi dovremmo realizzare, a mio parere, quella che, con un’espressione moderna, è chiamata un'aula verde. Il vero obiettivo dovrebbe essere quello d’istituire un laboratorio didattico finalizzato all'educazione ambientale in cui è fondamentale il ruolo della scuola.
Una circolare ministeriale (n° 49 del 4 febbraio 1989) suggeriva che "l'educazione ambientale deve stimolare negli studenti una particolare sensibilità per i problemi legati all'ambiente. La nuova cultura deve portare i giovani a nuovi comportamenti diretti alla salvaguardia dell'ambiente ed all'uso razionale delle risorse naturali, partendo dalla concezione dell'ambiente come patrimonio comune e della nazione e dell'umanità, che va correttamente fruito e gestito con l'attiva partecipazione di tutti i cittadini."
L'educazione ambientale non può prescindere dallo studio dell'evoluzione che l'ambiente ha subito col passare del tempo, ossia da una ricerca che prenda in esame non solo dati scientifici, ma tutti gli aspetti naturalistici, storici ed economici del territorio.
Occorre, insomma, presentare la valle del F. Bosso non solo per i suoi aspetti naturalistici, ma anche per il suo paesaggio umanizzato individuando i rapporti intercorrenti tra uomo ed ambiente, le testimonianze del passato, i processi che hanno determinato l'attuale configurazione territoriale ed infine le possibilità di usare in modo razionale il territorio consentendone lo sviluppo senza compromettere le risorse storiche e naturali.
Don Mariano Mariotti
Don Mariano Mariotti è stato il primo geologo della valle del F. Bosso.
Sacerdote della diocesi di Cagli, don Mariano insegnò lettere nel seminario diocesano fino al 1868 quando fu nominato priore di Secchiano.
Aveva cominciato a raccogliere fossili dall'autunno del 1862. Quasi certamente fu il prof. dom Raffaele Piccinini, monaco avellanita, che aveva fondato a Pergola la stazione botanico-geologica del Catria, a guidare don Mariano nelle prime raccolte e nelle prime determinazioni degli esemplari.
Tramite il Piccinini, don Mariano conobbe il prof. Giuseppe Meneghini dell'Università di Pisa, al quale scrisse, per la prima volta, il 26 novembre 1864 comunicando il possesso di fossili che poteva inviare a Pisa a scopo di studio o cambi.
Il prof. Meneghini, in quel momento, stava preparando una monografia sulle ammoniti del Rosso Ammonitico dell'Appennino centrale e della Lombardia. Nella prima lettera che scrisse a don Mariano si sente il tono dell'esperto che scrive al dilettante al quale raccomanda, tra l'altro, di indicare esattamente la provenienza degli esemplari. Aggiunse che don Mariano poteva "omettere interamente il nome della specie".
Nella seconda lettera, scritta per assicurare di aver ricevuto il materiale, il Meneghini è pieno d'entusiasmo e di gratitudine verso don Mariano il quale gli aveva sicuramente spedito dei bellissimi esemplari. Scrisse infatti: "Mi affretto a ringraziarla di così ricco e bello lucro. Può immaginare se immediatamente ho preso cognizione del contenuto e se mi sono schierato dinnanzi tutti quei tesori s'una gran tavola sbarazzata appositamente dalla folla di libri e dagli oggetti che da mesi e mesi vi si erano accumulati sopra. Posso anzi dirle di più, che, quantunque siano appena passate due ore dacché ho ricevuto la cassa, ho già fatto una prima divisione per ispecie o almeno per gruppi…Parecchi belli esemplari ed alcune interessanti specie hanno colpito ed hanno maggiormente attirato la mia attenzione…Studiando poi ulteriormente ogni cosa troverò certamente altri oggetti notevoli che in una prima rivista generale mi sono forse sfuggiti…Vivissime e sincere grazie io le rendo ed in nome mio ed in quello della scienza…"
Cominciò così un'amicizia tra il professore ed il dilettante di paleontologia che doveva durare fino alla morte di don Mariano.
Una parte dei fossili inviati a Pisa furono descritti e figurati dal Meneghini; altri esemplari furono successivamente descritti e figurati da Alberto Fucini.
Il 22 aprile 1868, il prof. Meneghini scrisse a don Mariano che il prof. Karl Alfred Zittel dell'Università di Monaco di Baviera desiderava venire in Italia per studiare la geologia dell'Appennino Centrale e, in particolare, gli interessava "vedere in posto il Giura superiore, cioè tutto quello che si può trovare fra il Lias superiore e il Neocomiano…Non essendomi possibile accompagnarlo, scriveva il Meneghini, come tanto vivamente desidererei, a lei mi rivolgo pregandola di essergli di guida o almeno di consigliarlo e dirigerlo nelle sue gite."
L'incontro fra don Mariano e lo Zittel fu vantaggioso per entrambi: don Mariano imparò moltissime cose sui fossili, potè far deteminare i suoi esemplari da un eminente paleontologo e potè approfondire la conoscenza della stratigrafia del M. Nerone; Karl A. Zittel trovò una ricca collezione di fossili ed un appassionato studioso che gli indicò importanti località fossilifere con grande risparmio di tempo e di lavoro. Le preziosissime informazioni di don Mariano furono poi utilizzate dal prof. Zittel per la sua monografia sulle ammoniti dell'Appennino Centrale.
L'attività scientifica e la collezione dei fossili di don Mariano furono così note a più studiosi che si rivolsero a lui per informazioni o per cambi.
Scriveva il Mici nel 1873: "A Secchiano, villaggetto a tre miglia da Cagli, quel parroco pievano don Mariano Mariotti da sé ha ricercato infaticabile quei monti e con zelo assiduo formato una raccolta di numerosi fossili e ben determinati e ritrovato importanti documenti paleontologici per la determinazione già prima incerta di alcune rocce secondarie." Dopo la morte di don Mariano, avvenuta il 20 febbraio 1876, la collezione fu affidata a don Gregorio Mei, come ricorda Guido Bonarelli.
I libri di geologia e di paleontologia furono invece depositati nella biblioteca comunale di Cagli.
Da allora, ogni tanto, qualcuno si ricorda della collezione di fossili di don Mariano.
In un numero della rivista "Il Catria" (anno 2, n. 5, 1899) si ricordava che: "Lunghi anni di premurose ricerche tra le rocce dei nostri monti gli fruttarono una splendida collezione di fossili ch'egli arricchì con esemplari di altre località. Questa collezione è in proprietà del patrio municipio e trovasi precariamente in una sala del teatro. L'amministrazione comunale se provvederà che questi importantissimi documenti siano ordinati con rigore scientifico e degnamente riposti potrà dire di avere ben meritato della scienza non che della memoria di questo illustre cittadino".
Nel 1909, mons. Tarducci aggiunse: "È cosa veramente desiderabile che i reggitori del Comune vengano a qualche determinazione per la custodia di questi ed altri oggetti che giovano non meno all'incremento degli studi storici che al decoro della propria città. Io vorrei s'imitasse l'esempio di altre città anche minori che sono tutt'occhi a raccogliere in un sol luogo e ordinare ogni documento, ogni passo che serva a rinfrescare le vecchie tradizioni e a difendere dalle ingiurie del tempo le reliquie di un passato non inglorioso e a tener vivo il culto delle memorie patrie".
Nel 1943, il Buroni ricordò che "la splendida collezione di fossili giace disprezzata in una sala del patrio municipio". Qualche anno dopo, Osvaldo Pedriali, cronista cagliese, rammentò che "la collezione si trovava sistemata molto precariamente in una soffitta del teatro."
Il 19 maggio 1972 io e Franco Aguzzi ritrovammo la collezione di fossili in un'altra soffitta di un istituto scolastico cittadino.
Depredata, in parte distrutta, in parte emigrata verso altre città, la collezione dei fossili di don Mariano attende ancora una degna sistemazione.
NOTE
(1) In questo capitolo ho tenuto conto delle informazioni botaniche riportate nei lavori di Ballelli S. et al. (1981) – Il patrimonio vegetale delle Marche, ed inoltre di Brilli Cattarini et al. (1981).
(2) Tortonese E. (1975) - Osteichthyes - Pesci ossei (parte seconda), Fauna d'Italia, v. 11, p. 456.
(3) Gabucci L., Para R. & Poselli M. (1990) – Pesci e crostacei d’acqua dolce della Provincia di Pesaro-Urbino. Circolo Culturale “Naturae”, vol. 91 pp., fig. n.n., Villa Verucchio (FO).
(4) Ferretti A. (1972) – Ricerche biostratigrafiche sul Domeriano nel gruppo montuoso del Nerone (Appennino marchigiano). Riv. Ital. Paleont. Strat., v. 78, n. 1, pp. 93-130, t. 6. Milano.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 17.06.2012
Ultima modifica: 17.09.2012
Nessun documento correlato.