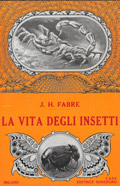Opere specialistiche
Opere specialistiche
Storie di piccoli animali (1957 -1958): il Ragno lupo, il Ragno botola, l'Ape tagliatrice di foglie e la Crisopa, di LUCIANO POGGIANI
Storie di piccoli animali (1957 -1958): il Ragno lupo, il Ragno botola, l'Ape tagliatrice di foglie e la Crisopa
Brani del testo già pubblicati in POGGIANI, 2024 (1).
Citazione bibliografica: POGGIANI L., 2025 - Storie di piccoli animali (1957 - 1958): il Ragno lupo, il Ragno botola, l'Ape tagliatrice di foglie e la Crisopa. In: "La Valle del Metauro - Banca dati sugli aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro", http//www.lavalledelmetauro.it. Ed. Associazione Naturalistica Argonauta e Comune di Fano, Fano (PU).
I piccoli animali: moltissimi e poco conosciuti
Tutt’attorno a noi le specie di piccoli animali pluricellulari sono migliaia, ben più numerose di quelle dei vertebrati, e ciò vale anche per un ambito ristretto come quello attorno a Fano. Il maggior numero di esse appartiene al phylum degli Artropodi (Insetti, Aracnidi, Miriapodi, Crostacei, ecc.). Considerando poi anche le acque marine, il loro numero aumenta perché vi si aggiungono i Poriferi, i Cnidari, gli Echinodermi, ecc. E questo senza contare quelli piccolissimi e unicellulari (batteri, protozoi, ecc.).
A parte le farfalle che ci attirano per i loro colori, ci accorgiamo in genere di loro solo quando creano danni, pungono o danno fastidio. Ma guardarli da vicino è scoprire un mondo nuovo incredibilmente vario e interessante.
Tra i primi scritti sulla natura che ho letto a fine anni ’50 del secolo scorso sono stati i tre libri di Jean-Henri Fabre (1823-1915) pubblicati in Italia dalla Sonzogno nel 1956-1957, contenenti brani scelti dell’opera più vasta “Souvenirs entomologiques” in undici volumi uscita in Francia tra il 1879 e il 1907. Ho anche scoperto nella libreria Bazzani in piazza a Fano i cinque libricini di Marcel Roland pubblicati dalla Rizzoli nella collana B.U.R. dal 1949 al 1953: “La grande lezione dei piccoli animali”, “Le meraviglie del microscopio”, “Canti d’uccelli e musiche d’insetti”, “Vita e morte degli insetti” e “Amore, armonia e bellezza”, che consiglio per una piacevole lettura. Ebbi anche in regalo “Gli animali e la loro vita” di Leon Bertin, due ponderosi volumi a carattere divulgativo ma di buon livello scientifico pubblicati nel 1953 dall’Istituto Geografico De Agostini. Ma il regalo più ambito, a 15 anni e in prima liceo, è stato nel 1958 il microscopio. Comperato in un negozio di ottica a Fano, non era evidentemente paragonabile a quelli che ho poi usato all’Università, ma aveva comunque una torretta girevole con tre obiettivi e una cassetta di legno come custodia. Questo strumento mi ha permesso di entrare nel mondo dei microorganismi acquatici che prelevavo dalla patina verde nelle vasche all’aperto. In quel periodo avevo già dei quaderni dove annotavo le mie osservazioni sugli animali che popolavano il giardino di casa, la spiaggia e la campagna vicina. Nel 1960 per fotografare i piccoli animali ho costruito una ingombrante macchina fotografica di cartone verniciata di nero il cui obiettivo era una lente d’ingrandimento con manico, e poco dopo un’altra più efficiente adattando alla macro una fotocamera di plastica della Ferrania. La reflex acquistata anni dopo, una Praktica dotata di tubi di prolunga per aumentare l’ingrandimento, ha finalmente risolto i problemi tecnici che avevo prima.
Il Ragno lupo
Nel 1958 mi è capitato di poter osservare in terrario il comportamento materno di un Ragno lupo appartenente alla famiglia dei Licosidi, catturato sui prati del Monte Nerone (Appennino Umbro-Marchigiano). Dai miei appunti su carta quadrettata, che ancora conservo, ho tratto questi brani. “L’ho trovata in un prato del Nerone nel settembre 1958: si tratta di una grossa femmina che era intenta a scavare il suo pozzo nel terreno coperto di erba fitta e rasata. Ho osservato diversi di questi pozzi sul prato, di vario diametro a seconda dell’individuo che vi risiedeva, perpendicolari al terreno e senza botole di chiusura. Nel buio della cavità a volte ho intravisto gli occhi scintillanti del ragno.
Messa in terrario, dopo qualche giorno ha iniziato la costruzione del sacco ovigero. Per prima cosa tesse un disco della grandezza di una moneta da 100 lire (2,8 cm), formato da uno spesso strato di bianca seta ben teso mediante un’impalcatura provvisoria di fili fissata alle asperità del terreno. I bordi del disco sono più sottili e sfrangiati. Tessendo strato su strato, man mano forma un bordo rialzato tutt’attorno, in modo che ne risulti una specie di scodella. Ultimata la costruzione, vi depone le uova, in una sola emissione. Quindi vi tesse sopra uno strato di seta che si unisce ai bordi rialzati del disco sottostante formando un sacco chiuso. Alla fine stacca il sacco dall’impalcatura di fili e facendolo ruotare adagio con le zampe anteriori ne piega coi palpi e i cheliceri il bordo sporgente e lo arrotonda: ne risulta una specie di cialda bianca che alla fine fissa verticalmente alle sue filiere all’estremità dell’addome. Col passare del tempo il sacco ovigero si sporca e inoltre compare una tinta azzurrastra dovuta alle uova che maturano viste per trasparenza. Dopo circa un mese ho trovato la covata schiusa, coi piccoli ragni tutti riuniti sul dorso della madre e il sacco ovigero appallottolato a terra. La licosa, affamata dal lungo digiuno, in breve tempo ha divorato una forbicina, un grillo e una grassa larva di cetonia. I ragnetti, stretti gli uni agli altri e anche uno sopra l’altro, formano una spesso strato marrone in groppa al genitore. Quando la madre compie un movimento brusco, entrano in agitazione portandosi fin sopra le zampe ed anche a terra, ma poco dopo risalgono sul dorso. A novembre hanno cominciato a scendere più spesso e a tendere ovunque i loro fili negli spostamenti, a fine mese hanno tutti abbandonato la madre e li ho liberati.”
Nel 1958 non sono riuscito a capire di quale specie si trattasse e poi non ho più avuto modo di osservarla.
Il Ragno botola
Gli unici incontri con un Ragno botola sono avvenuti nel 1957, a Fano nel giardino di casa mia. Dai miei appunti: “Il ragno è di taglia medio-grossa, di un colore marrone-scuro, ma le sue caratteristiche non le ho potute studiare se non di sfuggita poiché non sono riuscito a catturarlo. La sua tana è formata da un pozzo a sezione circolare che si addentra profondamente nel terreno, obliquo nel primo tratto. Le pareti sono lisce e ricoperte da seta biancastra che impedisce alla terra di franare e permette molto bene alle zampe del ragno di far presa, cosicché può salire e scendere rapidamente. Nella parte superiore è posta una botola circolare della grandezza di una moneta da 50 lire (1,6 cm) che combacia esattamente con l’orlo di seta del pozzo. La botola è attaccata per un tratto all’orlo e si apre e si chiude a seconda della volontà del ragno. All’esterno della botola è fissato alla seta uno strato di terriccio con un risultato di mimetizzazione molto buono, tanto che se ne può scorgere appena una leggera linea semicircolare. Il ragno può anche trattenerla dall’interno per impedire che si apra. Una sera stavo osservando una forbicina mentre saliva sul gambo di una rosa e scuotendo la pianta l’ho fatta inavvertitamente cadere. Quando fu quasi al centro dell’aiuola successe l’imprevisto: un corpo scuro si protese rapidamente in avanti, afferrò la forbicina e scomparve come d’incanto, inghiottito dalla terra. Non riuscivo a capacitarmi: guardai più attentamente il terreno dove era avvenuto il dramma ed infine scorsi a mala pena il contorno della botola ed intuii il sistema di caccia del ragno. Di giorno se ne sta nella parte più profonda del pozzo oppure verso metà, ma di notte sale nella parte più alta e con la botola semiaperta spia dalla piccola fessura il terreno attendendo che una preda gli capiti a tiro.” Si tratta di un Ragno botola appartenente alla famiglia degli Ctenizidi oppure dei Nemesidi.
Da allora non sono più riuscito ad osservarlo, effettivamente averlo incontrato è stato un caso del tutto fortuito.
L’Ape tagliatrice di foglie (genere Megachile)
E' un Imenottero della famiglia dei Megachilidi. Dai miei appunti: “27 ottobre 1958, in una canna aperta ad un’estremità, di quelle che sorreggono i fiori in giardino, ho trovato un nido di Megachile formato da frammenti di foglie di una campanella posta a pochi metri di distanza. Altri nidi osservati sono fatti con foglie di rosa e petali di geranio. Le celle sono disposte l’una sopra l’altra come bicchieri impilati. In alto presso l’apertura della canna le celle sono protette da uno strato di foglie ritagliate e pressate. Ogni cella contiene del miele color giallo e dentro un uovo o una larva.” Ho visto di frequente delle foglie con porzioni tagliate via da questo imenottero per usarle nella costruzione delle celle per la prole, ma dopo il 1958 non ho più avuto occasione di imbattermi nei suoi nidi.
La Crisopa
Nel 1957 uno dei primi animali che ho potuto osservare a lungo e in maniera approfondita è stata la Crisopa, elegante ed esile insetto che frequentava il giardino di casa mia a Fano. Estraggo i brani e i disegni che seguono dal quaderno di appunti a quadretti che ancora conservo, dai quali in alcuni passaggi traspare lo spirito e il linguaggio del neofita.
Non avendo conservato gli esemplari, per quanto riguarda la specie osservata neanche oggi saprei dirlo con certezza, comunque si tratta di un Neurottero della famiglia Chrysopidae.
Le uova
Si trovano sulle piante infestate dagli afidi. Sono sostenute da un peduncolo filiforme lungo poco più di un centimetro, diritto ma flessibile. Sono allungate, ovali, lunghe 1 mm, dapprima verdi e poi, vicino alla schiusa, lilla-bruno.
La larva
E’ un’insaziabile divoratrice di afidi: li afferra con le lunghe mandibole e li svuota in poco tempo ad uno ad uno. E non attacca solo afidi, ma anche altre larve. L’ho vista divorare, non del tutto però, due piccole larve brune dal dorso ricoperto di lanugine bianca. Poi ha preso un po' di quella lanugine con le mandibole e inarcando all’indietro la testa se l’è messa sul dorso coperto di radi peli. Già prima ne avevo osservata una con dorso ricoperto di spoglie di afidi e in seguito ho voluto esaminare meglio cos’altro si metteva sul dorso: oltre agli afidi, c’erano resti della corazza e zampe di piccoli coleotteri, formiche intere e a pezzi, la testa di un bruco residuo della muta. Ho provato a togliere ad una larva le minuzie che aveva sul dorso e a fornirle in prigionia piccole scorie di legno e di fibre: in breve è tornata a ricoprirsi con quello che ha trovato, ritenendo indispensabile questa operazione. Ha scelto anche una fibra lunga più di un centimetro che le ostacolava alquanto i movimenti!
La larva per camminare si aiuta col codione; il corpo è grasso, ricoperto di radi ciuffi di peli scuri; la colorazione è marrone-grigio variegato di grigio chiaro. Le mandibole sono arcuate, lunghe e sottili, le zampe pure sottili, la testa piccola e la parte ventrale chiara. Quando ha raggiunto il suo massimo sviluppo, più di un centimetro, sale su di un muro e si rifugia entro una fessura o altro riparo.
Il bozzolo
Una delle due larve messe in un vasetto di vetro per osservarle, la più piccola, non avendo altro riparo disponibile ha intessuto durante la notte il bozzolo tra gli ovari del finocchio selvatico che ho messo all’interno. La larva più grossa si appresta ad intessere il bozzolo nella mattinata. Ha cominciato dapprima a tendere senza ordine pochi fili tra gli ovari, a sostegno del bozzolo, ma poco dopo abbandona il lavoro e lo ricomincia accanto. Con la seta che emette dal codione intesse attorno a sé un riparo, ancora rozzo, e lo modella dall’interno, tenendo il corpo in posizione arcuata e inspessendo e levigando man mano lo strato. Il corpo ruota lentamente per offrire al codione tutta la superficie. Infine i due bozzoli sono terminati ed appaiono bianchi e un po' lanosi.
L’attesa
Per un certo periodo la larva mantiene il suo aspetto, ma poi a poco a poco il suo corpo si fa molliccio ed occupa tutto l’interno del bozzolo. La pelle si fa giallastra e sottile, di colore quasi uniforme. Il tutto si presenta quasi come un uovo … col pulcino dentro. Quando l’insetto dovrà uscire premerà dall’interno su una zona rotonda, delimitata da un più leggero spessore, e così il coperchio si potrà staccare. Il colore della larva è diventato giallo-limone, con zone un poco più scure sul dorso. La pelle si fa raggrinzita e la Crisopa non fa più alcun movimento.
La ninfa
Con l’ultima muta la Crisopa appare allo stadio di ninfa e la pelle della larva è accantonata sul fondo del bozzolo, informe e scura. Dapprima la ninfa mantiene la colorazione giallo-limone, poi i suoi colori si animano: nella testa spiccano i grandi occhi con le tinte verde e rosso metallico dell’adulto, rotondi e sporgenti come due capocchie di spillo. Le antenne sono biancastre, contorte e aderenti al dorso. Le ali appaiono come uno strato appiattito e spesso, verde-chiaro splendente ed uniforme, mentre il resto non è molto cambiato. Queste crisope, impupatesi in autunno, diventeranno adulte nella primavera.
La schiusa
Quando il tempo è arrivato, la ninfa preme sul coperchio del bozzolo sino a sollevarlo e alla fine esce fuori. Lo sforzo le richiede un po' di riposo, ma subito dopo incomincia a muoversi sino a raggiungere un punto più alto, come può essere la sommità di uno stelo, più vicina al sole.
Anche la Crisopa che è uscita dalla crepa del muro sale più su: avanza in linea retta, si ferma un poco muovendo ritmicamente il corpo, riprende a salire e infine si ferma definitivamente, disponendosi saldamente con le zampe ancorate al substrato. A questo punto comincia a premere sulla pelle che la imprigiona come una camicia per uscire sfilandosi dal davanti. Con movimenti ritmici a poco a poco ne viene fuori, e nello stesso tempo sfila le sue antenne che stavano all’interno. Per far questo ne afferra ritmicamente con le mandibole un tratto e lo tira in avanti sino a che non sono estratte del tutto. La Crisopa ora è fuori nel suo stadio di adulto e si scosta un poco dalla pelle della ninfa che ancora mantiene la forma primitiva, ferma al momento in cui se ne stava con le sei zampe abbarbicate al muro.
Il bozzolo vuoto
E’ lungo circa 5 millimetri, biancastro, perfettamente ovale. Appare ora nettamente tagliato ad una estremità. Il taglio alle volte non è netto, ma invece di formare un cerchio, termina un po' più sotto; il “coperchio” si trova vicino al bozzolo, oppure ancora attaccato di poco ad esso; nel suo fondo si vede pressata la pelle dell’ultima muta.
Il volo
La Crisopa compie timidamente i primi passi, ascugandosi al sole primaverile, tutta soffusa di verde. Sembra quasi impossibile un insetto come questo - il corpo è lungo 7 mm, ma dalla punta delle antenne all’estremità delle ali chiuse arriva a 2 cm - possa essere stata contenuta in un bozzolo così piccolo. Le ali, prima sgualcite, umide ed opache, ora sono tese e lucide, pronte al volo. Ed ecco che parte: spicca un breve volo, si riposa sotto una foglia, riprende il volo e si allontana.
L’adulto
Di Crisope ne ho trovate diverse durante il giorno nei giardini e nei prati, in genere sotto le foglie. Il loro volo non è rapido, ma breve ed ineguale. Di notte sono attirate dalle luci delle case. Quando vengono molestate lasciano tra le dita un odore non sgradevole. Il loro colore è verde più o meno intenso, in alcune tendente al giallastro. Le ali sono grandi, con riflessi iridescenti, disposte a tetto in posizione di riposo. Gli occhi sono grandi sferici, sporgenti, verde smeraldo di sopra e rosso vivo di sotto. Le antenne sono lunghe circa come il corpo.
BIBLIOGRAFIA: (1) POGGIANI L., 2024 - Compagni di viaggio - uomo & natura a Fano e dintorni 1955-2024. Collana “I libri del Lago Vicini” n.13, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 528 pp.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 09.04.2025
Ultima modifica: 04.11.2025
Nessun documento correlato.