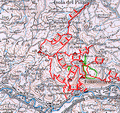Itinerari
Itinerari
I Monti della Cesana (itinerari - ESCURS)
Fossombrone e i Monti della Cesana
A chi, provenendo dalla costa fanese, giunge ai primi contrafforti del subappennino marchigiano, si rivela una grande gibbosità ricoperta di boschi con ai piedi una cittadina dal gradevole aspetto: Fossombrone.
Questa città,
ricca di testimonianze storiche, ha origini romane. Fu denominata anticamente
Forum Sempronii, probabilmente dal nome del tribuno Caio Sempronio Gracco, il quale
venne nel 133 a.C. per verificare l'attuazione della Legge Agraria che, in
seguito, fu causa di lotte politiche e della morte del patrizio romano.
La civitas sorgeva alle porte dell'attuale
abitato, in località S. Martino del Piano, sul percorso della via Flaminia; ebbe
la dignità di Municipio romano. Un pregevolissimo avanzo del selciato è
visibile presso la chiesa della borgata. Fossombrone conobbe nell'epoca
imperiale il massimo periodo di splendore, come testimoniano i reperti
archeologici conservati nel Museo cittadino.
Con la caduta di Roma e le successive ondate di invasioni, inizia per
queste contrade, come per l'Italia intera, un lungo, tremendo succedersi di
guerre, carestie, distruzioni.
Conquistata e saccheggiata dai Goti nel V
secolo, la città passò sotto la
giurisdizione dell'Esarca di Ravenna, poi fece parte della Pentapoli Annonaria
con Urbino, Cagli, Gubbio e Jesi. Di nuovo distrutta dai Longobardi di
Liutprando nel secolo VIII, venne ricostruita sul colle della Cittadella che
domina l'attuale abitato. Nel 999 passò sotto il potere della Chiesa, con il
Papa Silvestro II.
Nei primi anni del XIII sec. la Famiglia d'Este ne fece un proprio feudo
con Azzo VI e suo figlio Azzo VII. Quest'ultimo molto opportunamente decise di
subaffittare al Vescovo locale le proprietà marchigiane, per poterle tutelare
dalle mire espansionistiche di altre famiglie nobili della zona. Era, però,
destino della città subire altre dominazioni.
Il Cardinale Albornoz assegnò per investitura l'intero territorio alla
casata Malatesta con l'intenzione di ricondurre all'ubbidienza, nei confronti
della Sede Apostolica Romana, il turbolento e scarsamente affidabile popolo
delle Marche.
I Malatesta imposero nelle zone di loro
influenza il proprio vigoroso, duro governo e provvidero, in particolare nel
territorio forsempronese, a far edificare notevoli ed importanti
fortificazioni. Nel 1444 la città fu venduta da Galeazzo Malatesta, signore di
Pesaro, al Conte Federico da Montefeltro; iniziò un periodo di prosperità,
promosso dall'illuminato Urbinate, con grande impulso all'attività dell'arte
della lana, della carta e della seta. Quest'ultima durerà addirittura fino agli
anni successivi alla seconda guerra mondiale, rivestendo un importante ruolo
nell'economia del posto. Fossombrone conobbe anche un notevole ampliamento
edilizio (Corte Alta, Corte Bassa, Palazzo ducale) e fu elevata a stabile
dimora della Signoria di Guidobaldo, figlio di Federico. Con i Duchi Della
Rovere si conobbero ancora anni di pace e prosperosa industriosità.
Nel 1631 con l'estinzione della casata, il ducato passò in toto a far
parte dello Stato della Chiesa, seguendo le vicende comuni a tante altre città
e contrade dell'Italia centrale fino all'annessione al Regno d'Italia nel 1861.
L'attività del luogo, prevalentemente
agricola, si svolgeva nei fondovalle, tuttavia anche su colli e alture
esistevano operosi insediamenti che traevano sostentamento da colture e
pascoli. In particolar modo sulle Cesane, con l'andar del tempo, lo sfruttamento
operato dall'uomo determinò l'impoverimento del terreno, già abbastanza
difficile da lavorare e di fragile costituzione. A ciò si unirono le mutate
condizioni climatiche, specie nel XIX secolo, con il conseguente abbandono dei
campi e il degrado del territorio. Per ovviare a tale situazione, si decise nel
1915 di rimboschire il comprensorio delle Cesane; a causa della guerra, nel
frattempo estesasi anche in Italia, si procedette forzatamente per le spicce.
Furono utilizzate per l'impianto specie resinose di rapida crescita, non
tipiche del posto, e per manodopera si
impiegò quella a basso costo e discretamente abbondante fornita dai prigionieri
di guerra austro-ungarici. Tale primo intervento, condotto da alcune centinaia
di uomini che fino a poco prima erano stati costretti a distruggere ed
uccidere, fu ripetuto in successive volte tra le due guerre e nei primi anni
Cinquanta. Ancor oggi continua l'opera del Corpo Forestale, questa volta
impegnata anche nella parziale conversione delle resinose usate nei
rimboschimenti precedenti, con specie autoctone.
In definitiva questo bosco dall'aspetto e
dalla genesi singolari, con l'attraente alternarsi di pini, abeti, carpini,
aceri, roverelle e faggi, merita di essere visitato per vivere alcune ore di
pace e serenità.
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 01.01.1999
Ultima modifica: 22.01.2008
Nessun documento correlato.