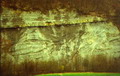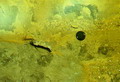Geologia e clima
Geologia e clima
Particolari della Formazione Marnoso-Arenacea
Marnoso - Arenacea delle aree di bacino interno
La Marnoso-Arenacea interna si è depositata nel Bacino Periadriatico durante il Miocene. Tale bacino era allungato in direzione NW-SE, con una estensione longitudinale di circa 400 km e con uno sviluppo trasversale di almeno 60 km. Nell'area marchigiana la Marnoso-Arenacea raggiunge uno spessore massimo di circa 2000 m. Il limite litostratigrafico con la sottostante formazione dello Schlier è convenzionalmente posto alla base della prima coppia torbiditica arenite-pelite, ed ha un'età progressivamente più giovane man mano che si procede verso le zone esterne, passando dal Burdigaliano superiore (in Val Tiberina) al Serravalliano superiore (nella fascia a ridosso della Dorsale Umbro-marchigiana). La Marnoso-Arenacea contiene differenti litofacies che possono essere schematizzate come segue:
- Litofacies a: torbiditi silicoclastiche con paleocorrenti verso SE composizionalmente definibili subarcose;
- Litofacies b: torbiditi miste con paleocorrenti verso NW costituite da clasti calcarei organogeni e silicatici;
- Litofacies c: torbiditi silicoclastiche con paleocorrenti verso NW, composizionalmente definibili come arcose.
La litofacies "a" è ubiquitaria e volumetricamente prevalente. La litofacies "b" caratterizza l'intervallo stratigrafico langhiano, per uno spessore di circa 300 m, sopra al passaggio stratigrafico con lo Schlier e si intercala in modo occasionale nell'intervallo serravalliano. La litofacies "c" caratterizza un intervallo potente poche centinaia di metri in corrispondenza del passaggio Langhiano/Serravalliano, ed è presente solo occasionalmente nell'intervallo serravalliano. Un particolare strato delloa litofacies "b" di età Serravalliano inferiore viene individuato come livello guida e definito Strato Contessa. Questo strato presenta uno spessore del letto arenitico di circa 8 m ed un tetto pelitico di circa 14 m, ed è fisicamente correlabile da Gubbio fino a S di Bologna. Infine solo sopra lo Strato Contessa sono presenti alcuni strati con paleocorrenti verso NW composti essenzialmente solo da clasti carbonatici intrabacinali noti in letteratura con il nome di Colombine (Fig. 1).
Elvio MorettiSlump nella Marnoso-Arenacea interna
Il nucleo della struttura sinclinalica di Monte Pollo è costituito da un grande accumulo di frana sottomarina (slump). Lo slump si estende per oltre 5 kmq e, in corrispondenza dei suoi margini settentrionale ed orientale, raggiunge uno spessore di circa 30 m. Nell'affioramento lungo la SS 257 Apecchiese non è visibile la base dell'accumulo. Al suo interno è possibile distinguere una porzione inferiore costituita da una litofacies marnoso-arenacea, con pieghe e faglie sinsedimentarie, ed una parte superiore, prevalentemente marnosa, che mostra deformazioni più complesse. Gli orizzonti marnosi della parte inferiore presentano superfici di dislocazione con calcite fibrosa e locale clivaggio. L'orientamento delle strutture deformative sinsedimentarie indica che il fenomeno si è originato per scivolamento verso NE. L'intero accumulo di frana è livellato superiormente da un potente strato di calcarenite (Fig. 2).
Elvio MorettiLo strato Contessa nella cava di Lamoli
Presso Lamoli è ancora visibile il fronte di una cava ormai dismessa nella quale veniva coltivato l'intervallo arenaceo dello strato Contessa. I grossi blocchi che qui si ricavavano venivano utilizzati in passato, in virtù della elevata tenacità di questo livello, quale pietra da costruzione per realizzare stipiti, soglie, gradini, architravi, camini, ecc. Lo stesso strato si estraeva per produrre calce, dato che, grazie al suo elevato tenore in carbonato di calcio, rappresentava l'unica fonte consistente di approvvigionamento di questo minerale in quanto nelle zone di affioramento della Marnoso-arenacea non sono presenti formazioni calcaree. La produzione della calce necessitava ovviamente di un processo di calcinazione che veniva ottenuto in numerosissime piccole fornaci realizzate in prossimità dello strato stesso, sufficienti a garantire i limitati fabbisogni locali (Fig. 3).
Francesco VeneriLo strato Contessa a Borgo Pace
Questa torbidite calcareo-organogena silicatica risalta immediatamente fra gli altri strati per il suo elevato spessore che raggiunge circa 12 m e per l'eccezionale continuità (non apprezzabile, naturalmente, alla scala dell'affioramento) dato che questo strato si estende, per almeno 150 km, dall'area di Gubbio fino all'altezza del fiume Sillaro, nel bolognese, dove la Marnoso-arenacea scompare sotto le coltri liguri. Simili caratteristiche fanno di questa megatorbidite un importante livello guida del Serravalliano inferiore che consente una prima suddivisione della monotona successione della Marnoso-arenacea in due intervalli stratigrafici e permette, fra l'altro, utili valutazioni in merito all'assetto strutturale delle varie unità tettoniche in cui questa formazione è segmentata.
L'intervallo arenaceo, potente circa 5 m, appare grigio-ocra sulle superfici esposte ma nei tagli freschi è di colore grigio. Nell'arenaria compaiono tutti gli intervalli della sequenza di Bouma. Nel primo intervallo, quello gradato, i clasti raggiungono alla base dimensioni anche di alcuni mm, con gli elementi più grossolani che si concentrano soprattutto nelle prominenze di varia forma (impronte di fondo) presenti alla base dello strato. Queste impronte sono il calco di piccole docce di erosione che la corrente di torbida, scorrendo vorticosamente sul fondale marino, scavava sui soffici fanghi marnosi depositati dalla torbida precedente e non ancora litificati, oppure di solchi prodotti per trascinamento sul fondo di clasti o oggetti di altra natura che, per la loro massa eccessiva, la corrente non era in grado di trasportare in sospensione. La sabbia che successivamente ha riempito tali vuoti, fossilizzandoli, ha così creato le controimpronte da corrente oggi visibili alla base dello strato. E' qui possibile riconoscere anche macroscopicamente, grazie alle maggiori dimensioni del sedimento, granuli di quarzo, generalmente spigolosi, ossidi, miche e glauconite, si possono osservare inoltre frammenti di rocce di varia natura, specie quelle metamorfiche. Sono inoltre visibili bioclasti fra cui si possono a volte incontrare frammenti di gusci di Lamellibranchi; con l'ausilio di una lente è inoltre possibile riconoscere resti di Foraminiferi Questi caratteri macroscopici rispecchiano la composizione dello strato Contessa, classificato come arenite ibrida in quanto costituito sia da detrito silicatico sia da clasti e bioclasti carbonatici. Una simile composizione indica l'esistenza di due differenti aree-fonte, una piattaforma carbonatica ed un massiccio cristallino, che fornivano rispettivamente la frazione carbonatica e i silicoclasti. Esaminando forma e posizione delle controimpronte di corrente rispetto ai punti cardinali è possibile stabilire che il flusso torbiditico da cui ha preso origine lo strato Contessa scorreva da SE verso NW; il punto di immissione dei clasti va pertanto ricercato nei settori meridionali del bacino della Marnoso-arenacea (Fig. 4).
Francesco VeneriIl "Marker Guinza" a Figgiano
Il "Marker Guinza" è una torbidite calcareo-organogena silicatica dello spessore di circa 8 m, dei quali 3 del solo intervallo arenaceo, situata stratigraficamente 450 m al di sopra dello strato Contessa. La sua continuità tuttavia non è paragonabile a quella che caratterizza quest'ultima torbidite, e il suo carattere di livello guida è valido solo a livello locale.
La porzione arenacea è di colore grigio-nocciola che sulle superfici alterate assume una caratteristica tonalità avana giallastra, tipica di tutte le torbiditi carbonatiche; al pari di queste inoltre, a causa della elevata cementazione, lo strato non risponde alle sollecitazioni in maniera duttile come le arenarie silicoclastiche ma si comporta fragilmente. L'intervallo arenaceo appare così facilmente riconoscibile a causa della diffusa fratturazione che rende lo strato suddiviso in piccoli parallelepipedi. L'elevata cementazione conferisce inoltre una maggior resistenza all'erosione per cui il "Marker Guinza" si distingue rispetto altri strati, oltre che per il maggior spessore, anche per il risalto morfologico. Composizionalmente questo livello guida si colloca in posizione intermedia tra lo strato Contessa, in cui la frazione non carbonatica si aggira mediamente intorno al 45 %, e le "colombine", costituite prevalentemente da clasti e bioclasti carbonatici. Come per le torbiditi appena citate, anche il "Marker Guinza" mostra alla base dello strato controimpronte da corrente che indicano una direzione di scorrimento del flusso torbiditico verso NW, opposta quindi a quelle che caratterizzano l'apporto principale della Marnoso-arenacea (Fig. 5).
Francesco VeneriColombine lungo la strada Pianello - Pietralunga
Con il termine di "colombine" vengono indicate in letteratura delle torbiditi carbonatiche, poste stratigraficamente al di sopra dello strato Contessa, il cui intervallo arenitico, dal caratteristico colore giallo-avana si associa a marne calcaree di colore biancastro, talora con spalmature rossastre, che rappresentano l'intervallo pelitico di questa coppia torbiditica. Caratteristiche distintive di questo gruppo di strati sono la composizione, dato che risultano costituite essenzialmente da clasti e bioclasti carbonatici, e la provenienza, in quanto, a differenza delle arenarie silicoclastiche, di provenienza "alpina", che rappresentano l'apporto principale della Marnoso-arenacea, mostrano costantemente direzioni di scorrimento dei flussi dai quadranti meridionali, con probabile origine del detrito dalla piattaforma carbonatica laziale-abruzzese. L'insieme di tali caratteri e l'estensione bacinale degli strati di maggior spessore rende le "colombine" degli importanti livelli-guida (Fig. 6).
Francesco VeneriMarnoso-Arenacea esterna - successione di Urbania
Nell'area di Urbania la successione torbiditica tortoniana si sviluppa al di sopra di facies pelitico-arenacee del Langhiano sommitale che la letteratura attribuisce ancora alla Marnoso-Arenacea interna.
La successione esordisce con litofacies arenaceo-pelitiche quindi passa a litologie schiettamente arenacee, queste ultime indicate in letteratura come "arenarie di Urbania", che rappresentano probabilmente l'elemento più evidente e caratteristico di questo intervallo stratigrafico.
Le facies arenacee sono costituite da strati amalgamati di arenarie grossolane (ovvero da strati formati dalla sovrapposizione di un'arenaria sull'altra, senza l'interposizione dell'intervallo pelitico normalmente presente nella coppia torbiditica, eroso o non deposto a causa dell'elevata energia dei flussi torbiditici) la cui base risulta talvolta costituita da elementi microconglomeratici ("granitello" Auctt.) o addirittura da tasche di elementi ghiaiosi più grossolani, composti da frammenti di rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. Sono inoltre frequenti, sempre alla base degli strati arenacei, grossi clasti pelitici strappati dalla corrente di torbida allo strato precedente (rip-up clasts, clay chips) e inclusi marnosi o calcareo-marnosi probabilmente derivanti dallo Schlier o dal Bisciaro. Tali facies costituiscono nel loro complesso un corpo canalizzato molto grossolano facente parte di una conoide sottomarina confinata che ha riempito una depressione stretta ed allungata in direzione appenninica: la loro presenza è pertanto indicativa della posizione dell'area depocentrale del bacino. L'esame delle controimpronte da corrente (flute casts) osservabili alla base di molti strati permette di stabilire che la dispersione dei sedimenti avveniva con scorrimento dei flussi verso SE, con apporti esclusivamente di tipo "alpino".
Al di sopra delle facies canalizzate la sedimentazione torbiditica torna in un primo momento a facies arenaceo-pelitiche, quindi termina con una associazione pelitico-arenacea. Solo nel settore più occidentale si incontra un intervallo costituito da peliti, localmente indicate con il nome di "Argille azzurre", eteropico della facies pelitico-arenacea. Si tratta di sedimenti emipelagici indicativi del sollevamento in atto del settore occidentale del bacino che da zona depocentrale evolve verso ambienti di scarpata (nella quale i flussi torbiditici non riescono a risalire) con la conseguente cessazione della sedimentazione torbiditica. Indizi di tale sollevamento sono già evidenti entro le sottostanti facies arenaceo-pelitiche e arenacee della successione tortoniana per la presenza di più orizzonti di frana sottomarina costituiti da pacchi di strati appartenenti alle stratigraficamente sottostanti formazioni del Bisciaro e dello Schlier ed anche alla Marnoso-arenacea interna. L'estensione dell'ordine anche delle centinaia di metri di questi olistostromi rende, in certi casi, non propriamente semplice riconoscerne la posizione stratigrafica anomala, non più in successione normale con gli strati sotto e soprastanti. Ciò è ancor più vero quando i fenomeni di franamento sottomarino hanno coinvolto pacchi di strati di Marnoso-arenacea, litologicamente molto simili alla formazione entro cui si intercalano e pertanto mal distinguibili dalla stessa.
Gli olistostromi si incontrano principalmente a ridosso dell'anticlinale calcarea di M. Montiego (ed alla sua prosecuzione verso nord-ovest) che rappresenta il segmento più settentrionale della dorsale umbro-marchigiana. Questa struttura, l'unica da cui potevano prendere origine le frane sottomarine, doveva pertanto essere già almeno in parte delineata al tempo della deposizione della successione torbiditica. La presenza, entro le arenarie, di ciottoli, sempre costituiti dalle litologie calcaree del Bisciaro e dello Schlier, che mostrano un certo grado di elaborazione in ambiente litorale, sembrerebbe indicare l'emersione almeno parziale di tale struttura (Fig. 7).
Francesco VeneriMarnoso-Arenacea esterna - successione di Urbino
Nell'urbinate la Marnoso-Arenacea esterna si sviluppa direttamente al di sopra dello Schlier (anche se in effetti al tetto di quest'ultima formazione è presente un intervallo costituito da alcuni livelli di marne scure ad elevato tenore di sostanza organica contenenti resti di Pteropodi, del tutto simile, tranne che nello spessore, alle litologie della coeva formazione delle Marne a Pteropodi presente nella successione stratigrafica delle Marche centro-meridionali). Il passaggio tra le due formazioni avviene all'interno del Tortoniano.
La deposizione della Marnoso-arenacea esordisce con 5-6 m di torbiditi prevalentemente pelitico-arenacee (rapporto a/p < 1) quindi passa rapidamente ad una facies arenaceo-pelitica. Quest'ultima è caratterizzata da potenti strati arenacei, con spessori che raggiungono anche i 5 m. Sono di norma presenti tutti gli intervalli della sequenza di Bouma. Le arenarie, ad eccezione dei primi 5- 10 cm alla base, risultano in genere poco cementate. Sono frequenti gli inclusi marnosi con dimensioni fino a 30 cm. La porzione superiore degli strati, di norma laminata, contiene lamine di spessore millimetrico contenenti abbondanti frustoli vegetali carbonificati.
A questa facies ne segue un'altra, sempre arenaceo-pelitica ma caratterizzata dalla maggior potenza degli strati arenacei, con spessori fino a 6-8 m, che appaiono a luoghi amalgamati con forte riduzione della continuità laterale delle peliti al tetto degli strati, e dalla presenza di numerosi canali d'erosione con dimensioni fino a 6 m di larghezza e 2 m di spessore. Le superfici di amalgamazione sono di frequente evidenziate dalla presenza di inclusi pelitici e da nuvole microconglomeratiche, spesso concentrate nelle tasche d'erosione delle controimpronte da corrente, costituite da elementi a spigoli vivi di dimensioni comprese tra 2 e 5 mm. In questa facies si riconoscono tre grossi cicli trasgressivi evidenziati dalla graduale diminuzione di spessore degli stati arenacei.
L'ultimo ciclo sfuma gradualmente ad una facies pelitico-arenacea costituita da sabbie finissime, quasi al limite del silt, potente complessivamente 80 m sopra la quale, con un passaggio questa volta rapido, si sviluppa l'ultimo membro della locale successione costituito da grossi banchi potenti 20-40 m, formati da più strati arenacei amalgamati. Gli inclusi, già presenti nelle precedenti facies, raggiungono qui dimensioni veramente considerevoli, anche superiori a 80 cm, segno della elevata energia dei flussi gravitativi che depositavano le arenarie. Questo intervallo, dello spessore massimo di 100 m, non mostra una elevata continuità laterale ma si assottiglia fino a chiudersi nello spazio di pochi chilometri. Esso rappresenta pertanto il risultato del riempimento di una depressione probabilmente di origine erosiva e indica un ambiente di sedimentazione corrispondente alla parte più prossimale della porzione intermedia di una conoide sottomarina.
A tetto, questa facies passa direttamente alle unità della successione evaporitica, nello specifico al Calcare di base o al Tripoli, senza l'interposizione di intervalli marnosi quali, ad esempio, le Argille azzurre che caratterizzano la succesione nell'area di Urbania. Inoltre, nella porzione stratigraficamente più alta della Marnoso-arenacea dei settori più orientali, fra uno strato torbiditico ed il successivo si intercalano marne grigio chiare laminate, molto simili ai livelli diatomitici candidi del Tripoli, entro le quali sono stati rinvenuti piccoli resti fossili di ittiofauna, ad indicare addirittura una interdigitazione almeno parziale tra queste due formazioni (Fig. 8).
Francesco Veneri
Marnoso-arenacea esterna - facies amalgamate presso Urbania
Nell'affioramento sono visibili in dettaglio le facies arenacee massive del corpo canalizzato noto in letteratura come "Arenarie di Urbania". La stratificazione è riconoscibile solo grazie alla gradazione degli strati sabbiosi caratterizzati da porzioni basali estremamente grossolane (granitello) con granuli che arrivano a 4-5 mm di diametro, con contatti segnati da frequenti tasche erosive e da strutture da carico. La stratificazione è evidenziata anche da allineamenti di grossi clasti pelitici (rip-up clasts), che possono raggiungere la dimensione di un metro, e da rari ciottoli calcareo-marnosi di origine extrabacinale. Su tutto l'affioramento sono diffusi nuclei diagenetici (cogoli) generati da cementazione differenziata (Fig. 9).
Francesco Veneri
Dettaglio scheda
-
Data di redazione: 01.01.1999
Ultima modifica: 23.11.2004
Nessun documento correlato.